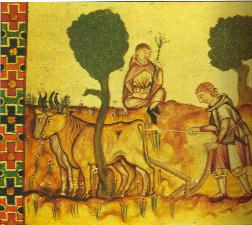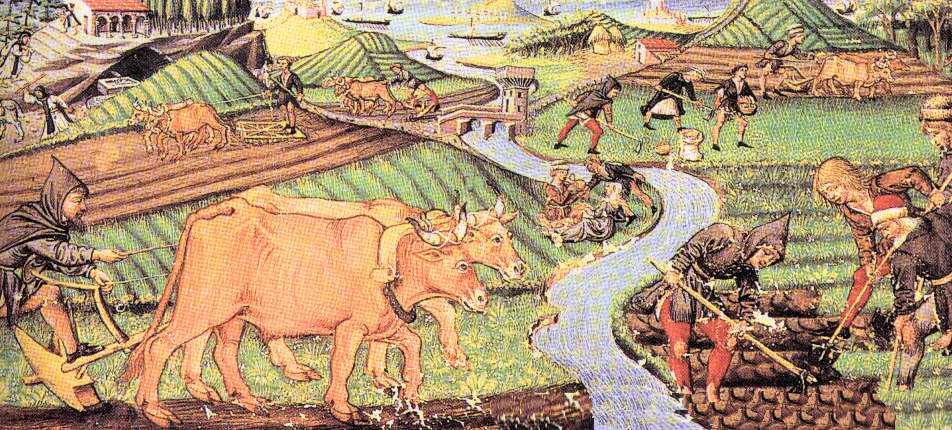MUORE PAPA GIOVANNI
LA SINGOLARE FINE DI TEODORICO
AMALASUNTA EREDITA IL TRONO
GIUSTINIANO E LA BALLERINA TEODORA
Rientrato da Costantinopoli a Ravenna, dopo aver fatto l'ambasceria di Teodorico, e non avendo portato con se' un nuovo editto dai contenuti desiderati dal re ostrogoto, soprattutto sul punto chiave (la non espulsione degli Ariani), Papa Giovanni fece infuriare Teodorico.
Se la prese con lui sbattendolo in prigione. Anziano, stanco e malaticcio il papa ci rimase pochi giorni, il 18 maggio usciva dalla galera, ma ne usciva cadavere.
Teodorico coglie subito l'occasione per far eleggere un papa di suo gradimento. Il 12 LUGLIO sale sul soglio FELICE IV, di origine sannita.
Poi si scatena, furente del fallimento.
Teodorico ha ormai 72 anni, ma vuole dare il colpo di coda. Osa contrapporsi all'editto di Giustino.
Prepara un editto e in questo è lui a mettere al bando tutti i cattolici; l'ordine è quello di cacciare da tutte le loro chiese i cattolici.
L'ordine porta una data: il 7 SETTEMBRE. E' il giorno che lui e il suo ministro tale esecuzione del bando doveva venire applicato.
Ma anche il destino ha fissato una data per la sua morte. Ed è la stessa il 7 SETTEMBRE.
Le sorti dell' Impero Romano e dell' Impero d' Oriente, subiscono un'altra volta una deviazione per un attacco di dissenteria a un suo protagonista, cosi come tanti altri, da Alessandro Magno in poi.
Una morte singolare, e la dominazione Ostrogota viene scossa dalle fondamenta.
I suoi fedeli cercano un successore. Tra i tanti parenti, resta solo la figlia Amalasunta, che ha un figlio avuto dal Visigoto di Spagna Eutarico, ATALARICO che sembra Teodorico prima di morire abbia indicato come suo successore.
Ma è ancora piccolo, e la reggente è la madre. Una gota di sangue ma di cultura ormai latina; è nata, cresciuta, educata, in un ambiente romano e sa cosa rappresenta Roma. Vorrebbe fare come il padre quando espresse la sua parte migliore.
Purtroppo deve fare i conti con i veri goti. Gli uomini di Teodorico in tutti questi anni si erano sottomessi al loro re, e come lui aveva insegnato, li aveva abituati a coesistere col mondo romano. Lo abbiamo letto più di una volta, Teodorico era un barbaro, ma aveva conservato le tradizioni romane; e nel mettere mano alle leggi, pur adeguandole alla sua gente, si era sempre avvalso di valenti magistrati del diritto romano; aveva portato rispetto alle istituzioni, e al Senato. Favorì perfino le passioni dei romani, come i giochi, gli spettacoli, le pantomine. Ma la cosa più sorprendente della sua personalità, singolare in un barbaro, fu quella di essere anche un uomo di buon gusto, amante dei monumenti, delle architetture degli edifici pubblici, e promosse anche molti restauri di quelli esistenti.
Gli storici Cassiodoro e l'Anonimo (lasciamo perdere Ennodio che usa troppa enfasi "Ringiovanì Roma e l'Italia, orrende nella loro vetustà"), ci elencano un numero incredibile di opere, erette a Roma, Verona, oltre a Ravenna. Era Teodorico stesso a ricercare con competenza marmi, marmisti, mosaicisti e architetti che hanno dato origine alle opere pregevoli che sono giunte fino a noi.
I suoi goti invece erano e rimasero barbari, e con la forza avrebbero voluto farsi valere di più. E fin quando Teodorico era vissuto li tenne a bada, ma ora salita una donna al trono, ritennero che era giunto il loro momento. Per prima cosa gli portarono via il bambino, che in seguito poi mori. La donna in difficoltà, anche perchè sollecitata a farlo, sperando di associare al trono un uomo fidato, scelse il male minore, quello di sposare il cugino TEODATO.
Che fidato non era, ma piuttosto perverso. Infatti si sbarazzò presto della donna relegandola su un isola del lago di Bolsena.
Amalasunta, eludendo la sorveglianza, riuscì a chiedere aiuto proprio a Giustiniano. Teodato avutone notizia la fece strangolare.
Ma a Giustiniano quell'invocazione gli arrivò comunque.
(ne riparliamo il prossimo anno)
GIUSTINIANO E LA BALLERINA
GIUSTINIANO compie quest'anno 42 anni. Abbiamo già letto nelle pagine precedenti che è un bell'uomo, almeno così è stato descritto e così ci appare in un ritratto ufficiale conservato nel mosaico di San Vitale a Ravenna; ma anche nel Dittico Barberini in avorio, che si trova oggi al Louvre.
Di carattere cordiale, non avvezzo alla mondanità di corte, oltre che avere la passione per il lavoro, aveva anche la passione di vivere una vita libera, consona alle sue origini contadine. Quindi non esitava a unirsi con amici quando voleva trascorrere allegre serate in compagnia, nè tralasciava di frequentare locali animati, pieni di vita godereccia. E fra questi locali non mancavano quelli dove si faceva musica, si ballava, dove c'erano ballerine; locali famosi con belle ballerine.
Giustiniano nel frequentarne uno, iniziò ad avere un debole per una ballerina che era fuori dal comune, avvenente, giovane, ammaliante da fare impazzire più di un uomo.
In breve divenne la sua stregata amante di cui non ne poteva fare più a meno.
La ballerina era TEODORA, figlia di un allevatore di orsi da circo, 18 enne. Tutte le sere si esibiva in un locale dell'ippodromo, affascinando ma anche scandalizzando la capitale, perché si esibiva in vestiti succinti, ballava e si adoperava in pantomime con scene audaci da far impazzire tutti i presenti.
La moltitudine dei suoi amanti, si sussurrava in giro, era enorme, ma una seccante avventura dicono i biografi maligni la fece sparire per qualche tempo da Costantinopoli (forse perché rimase incinta).
Ritornata dall'Egitto dopo un anno, più matura e più saggia, quando riapparve all'uomo che non l'aveva dimenticata, riuscì nuovamente a riconquistarlo. E quell'uomo era GIUSTINIANO che ben presto si trovò disperatamente innamorato di questa donna.
Giustiniano pur avendo (anche se sapeva controllarlo) un temperamento violento, e quel carattere decisamente autocratico (che poi esercitò), nei rapporti con Teodora si trasformò in un suo umile servo, non rifiutandogli nulla, colmandolo di ricchezze, facendosi distruggere dal suo odio-amore.
Il suo era un amore passionale possessivo, mentre l'altro era l'amore affettivo di una donna calcolatrice.
Ma lui non ne poteva fare a meno, e quest'anno, geloso e possessivo com'era, aveva deciso di averla tutta per sé, cioè di sposarla.
Ma c'erano le leggi costantine e ancora più severe quelle teodosiane, che non permettevano a uno di rango imperiale (ma anche a nessun cattolico) di unirsi in matrimonio con una attrice, fra l'altro dal comportamento non proprio irreprensibile.
Ma le leggi non le fanno gli uomini? E non c'era il vecchio zio GIUSTINO imperatore? E Giustino le faceva lui le leggi? Ma nemmeno per sogno! Fin da quando era arrivato il nipote non è stato altro che un suo subordinato; le leggi che il nipote gli prepara, Giustino prende il "nomografo" che gli hanno preparato in una sottile tavoletta e "firma" il suo nome seguendo la scanalatura.
Ma restiamo nelle apparenze formali. Giustino per compiacere il nipote prese le leggi in mano, ne abrogò la parte in questione che proibiva legami di senatori e alti funzionari con attrici e saltimbanchi, e permise al carissimo nipote ufficialmente di sposare la sua amante.
Quando il prossimo anno - dopo la morte dello zio- Giustiniano verrà incoronato imperatore, la stessa TEODORA fu incoronata Augusta imperatrice. Un fatto questo che ebbe parte determinante nell'indirizzare o nell'opporsi al corso degli eventi (politici e religiosi) di tutto l' impero.
Occorrerebbero molte pagine per illustrare la biografia di questa singolare donna che influenzò Giustiniano e l'impero per i restanti 22 anni di regno, tante sono i suoi interventi sulla politica, sulla religione, sulla cultura, sulla ricostruzione delle città, sui monumenti che ci sono giunti fino a noi.
Molti di questi anche a Ravenna, Milano, Roma e ovviamente a Costantinopoli i più grandiosi.
Teodora voleva passare ad ogni costo ai posteri, e i posteri la ricordano con i grandi monumenti, le basiliche (S. Sofia ), gli edifici pubblici, le terme e... anche dentro le leggi Giustiniane. Perché in quelle del divorzio, sulla prostituzione, sull'adulterio, Teodora non mancò di dare il suo contributo di "esperta". Conosceva l'ambiente, le debolezze umane, e i paradisi o gli inferni di una donna.
GIUSTINIANO parlando di ogni cosa del suo governò iniziava sempre "Io Giustiniano con la onoratissima moglie che Dio mi ha dato", oppure nel propugnare una legge, nell'esporla premetteva "il suo dolcissimo incantesimo mi ha suggerito...."
I suoi contemporanei sono d'accordo nell'affermare che essa non si faceva scrupolo di servirsi del suo influsso illimitato e che la sua autorità era pari a quella del marito, se non più grande.
Anche perchè i suoi biografi, anche quelli che gli hanno tessuto le lodi, non mancano di sottolineare che Giustiniano oltre che le qualità positive, aveva una volontà debole, una vanità infantile, un'indole gelosa (non solo riferita a quella amorosa), e un attivismo confusionale. Era inflessibile ma anche spesso vacillante. E mutamenti repentini di umore, dalle passioni più avventate, a quelle depressive.
La fama di Belisario ad esempio lo rose d'invidia per tutta la vita.
Mentre questa donna ambiziosa, ma molto intelligente, costante nella sua forza, possedeva molte eccellenti qualità che giustificavano il grande potere da lei esercitato fin dal primo istante quando a 18 anni lo conobbe e lo rese schiavo. Era dotata di un coraggio incrollabile, come dimostrò nella difficile occasione dell'insurrezione di Nika (mentre il marito impaurito fuggiva), di una grande energia, di una risolutezza maschia, di una mente decisa e limpida e di una forte volontà di cui spesso si serviva per dominare l'indeciso GIUSTINIANO (che nel suo attivismo confusionale non aspettava altro per togliersi d'impaccio)
A queste doti Teodora univa senza dubbio difetti e perfino vizi, essendo dispotica e dura, amante del denaro e del potere. Per conservare il trono su cui era salita, sarebbe ricorsa all'inganno, alla violenza e alla crudeltà, implacabile com'era nelle sue antipatie. Appassionata nei suoi amori come nei suoi odi, favoriva i propri protetti, ma stroncava gli altri senza scrupolo.
Scaltra e ambiziosa, voleva avere sempre lei l'ultima parola, e in genere si dice che ci riusciva. Mise mano a ogni questione politica e religiosa; in diplomazia GIUSTINIANO non decideva mai nulla senza il suo parere. Essa faceva e disfaceva a proprio piacimento Papi e Patriarchi, ministri e generali, e non temeva neppure suo marito, qualora lei non era d'accordo (come a Nika).
Nelle questioni femminili, lo abbiamo detto, intervenne di persona a mettere nelle riforme dei "Codici Giustiniani" le questioni che interessavano le donne, quindi misure sul divorzio, l'adulterio, la santità del vincolo matrimoniale; e quelle intese ad assistere le attrici (!) e le prostitute. Dotata per natura di istinto politico comprese perfettamente l'importanza che andava assumendo la "questione religiosa". Giustiniano se ne interessava studiando i problemi teologici, e gli piaceva parlare ai sinodi e ai concili dove interveniva di persona per pontificare con un estremo piacere le sue astratte teorie sulla unità delle due "nature" del Cristo, mentre invece TEODORA sapeva scorgervi in quei disaccordi gli aspetti essenziali dei problemi politici.
Seguace del monofisismo Teodora non riuscì a farlo trionfare. Ma non è tutto merito di Giustiniano se le cose andarono diversamente. Nel 533 al concilio di Calcedonia, Giustiniano fece condannare i Tre Capitoli, cercando di accontentare i monofisiti: in realtà la sua azione non portò ai risultati sperati perché creò uno scontento generale che aumentò la tensione preesistente.
Insomma per chiudere questa breve biografia, che occuperebbe cento pagine, e sarebbero ancora riduttive, basterà dire che se GIUSTINO ebbe bisogno di suo nipote per governare.
GIUSTINIANO ebbe bisogno di sua moglie TEODORA per fare altrettanto. E non sapremo mai se fu lui grande o se fu la moglie ad essere tale, o a ispirare o a sostituirsi a lui perché lo diventasse.
lunedì 11 agosto 2014
domenica 10 agosto 2014
ANNO 525
PAPA GIOVANNI A COSTANTINOPOLI
UN FALLIMENTO -E UNA VITTORIA
Come abbiamo anticipato lo scorso anno, TEODORICO, dopo l'editto di Giustino (la messa al bando degli ariani) sentendosi perso e quasi condannato non vuole finire così una carriera, ne vuole vedere la soppressione della sua religione nel suo regno:
Lui come sappiamo è stato sempre tollerante, ha permesso come ai tempi di Marco Aurelio che ognuno si occupasse della sua religione senza ostacolare quella degli altri, per il convivere civile, per la tranquillità del regno.
E che tale tolleranza dal popolo e dal clero di entrambi le due religioni, fosse ben accetta ce lo conferma un periodo di relativa tranquillità nel resto di tutta Italia.
Gli incidenti nell'arco di venticinque anni non sono in certi casi mancati, ma sempre circoscritti in alcuni territori; ovviamente Roma era quello più irrequieto, sia perchè c'era il papato, e sia perché convivevano due fazioni (l'aristocratica e la plebea) che si contrastavano fortemente soprattutto quando avvenivano le elezioni del pontefice. Ognuno voleva l'elezione del suo rappresentante.
I campioni nell'accendere la miccia nelle dispute, anche pretestuose, erano sempre gli ariani (la milizia barbara a Roma era notevole), gli ebrei (per altre ragioni), e i cristiani; quest'ultimi divisi fra l'altro in due correnti di pensiero, quella bizantina e quella cattolica.
E' dunque a Roma che scoppiavano continuamente liti violente, turbative nelle funzioni, incendio di basiliche, sinagoghe o chiese ariane. I tumulti spesso sconfinavano in vere e proprie battaglie cittadine con vittime da entrambi le parti. Lo abbiamo già letto, Teodorico si era sempre destreggiato nell'appianare questi contrasti, meritandosi anche molte lodi di saggio moderatore.
Del resto questi intralci venivano da personaggi ininfluenti, quindi le preoccupazioni erano realative. Era lui ad avere in mano lo stato, l'esercito, l'autorità.
Ma con l'editto, ora era tutto diverso. TEODORICO, ebbe la netta impressione che il mondo gli stava crollando addosso, non sapendo cosa fare, convinto che con l'editto sarebbe venuta meno anche la sua autorità, si rimette a Papa GIOVANNI per un intervento a favore di questa tolleranza che invece lui - questo voleva sottolineare- aveva sempre praticata. Ecco perchè invia proprio dei cristiani per intercedere presso l'imperatore.
Convinse così il Papa, cinque vescovi e quattro senatori a recarsi da GIUSTINO a Costantinopoli.
Abbiamo già letto lo scorso anno, che genere di complicità c'era nell'appoggiare questa nuova politica religiosa improvvisamente sortita da Costantinopoli. Teodorico era andato in collera, mandando al patibolo per tradimento presunto alcuni suoi stimati collaboratori. Che indubbiamente non agivano da soli (Oltre Boezio, quest'anno manda al patibolo anche suo suocero il senatore Simmaco).
In questo terrore seminato dalla collera di Teodorico, molti non si esposero più con i giudizi, si sottomisero al suo volere, soprattutto quelli che non erano dentro nell'ambiente del clero. Che quest'ultimo remasse contro il sovrano ostrogoto non era un mistero. La politica religiosa di Teodorico sulla penisola era sì stata tollerante, ma intanto le sue alleanze con i regni barbari iniziavano a preoccupare non poco. Ed alcuni storici giustificano i cattolici questo mettersi contro il sovrano, perché non dava a loro più nessuna garanzia. Come politicamente non le dava a Bisanzio. L'esercito in Italia era guidato da Teodorico, e lo stesso re ostrogoto aveva fatto di tutto per allearsi con gli eserciti dei regni barbari. Spesso dimenticandosi che era un delegato bizantino.
Teodorico mandò un suo esercito a dar man forte a Mundo un capo predone che dai Balcani seguitava a scendere con i suoi uomini a fare razzie a Bisanzio; il generale di Teodorico mise in fuga l'esercito bizantino che si era deciso ad attaccare il predone. Allo steso modo Teodorico si comportò quando una flotta di Anastasio volle attaccare le coste pugliesi e calabre; Teodorico schierò una sua flotta per contrastarla e metterla in fuga. Un delegato bizantino che si comportava così, con questa arrogante autonomia, e perfino con delle ostilità doveva eccome preoccupare Bisanzio!
La tesi che l'accordo (l'editto dell'espulsione degli ariani) sia stato fatto in complicità tra la chiesa Romana e Giustino viene abbastanza accreditata quando si legge dagli storici la cronaca dell'arrivo dell'ambasciata inviata da Teodorico a Bisanzio.
Papa Giovanni, all'arrivo a Costantinopoli, l'imperatore Giustino con una processione lunga 12 chilometri fuori dalle mura della città lo attese e lo ricevette in grande sfarzosa pompa. Spese quasi 300.000 solidi in elargizioni alla popolazione e per organizzare feste in suo onore, attirandosi la popolarità dei cittadini, dell'aristocrazia, del clero; tutti osannanti.
Il Papa illustrò, non sappiamo se con solerzia o con fastidio, la richiesta ambasciatoria che faceva TEODORICO; che era quella di riaccogliere nell'ambito della chiesa gli ariani che ne erano stati espulsi. Ma GIUSTINO (a parlare è sempre e comunque GIUSTINIANO ) confermò la propria intransigenza nei confronti dell'arianesimo. Alla fine gli ambasciatori lasciarono Costantinopoli senza aver cambiato proprio nulla dell'editto imperiale che quindi rimaneva in vigore in tutto l' impero. Teodorico al ritorno, avvenuto nei primi mesi del prossimo anno, infuriato se la prese con papa Giovanni; lo scaraventò in prigione. L'età, gli strapazzi del viaggio, più la galera gli furono fatali, il 18 maggio il papa moriva.
La tensione religiosa da questo momento si fa ancora più acuta. TEODORICO si scatena; ma non andrà molto lontano, come vedremo.
UN FALLIMENTO -E UNA VITTORIA
Come abbiamo anticipato lo scorso anno, TEODORICO, dopo l'editto di Giustino (la messa al bando degli ariani) sentendosi perso e quasi condannato non vuole finire così una carriera, ne vuole vedere la soppressione della sua religione nel suo regno:
Lui come sappiamo è stato sempre tollerante, ha permesso come ai tempi di Marco Aurelio che ognuno si occupasse della sua religione senza ostacolare quella degli altri, per il convivere civile, per la tranquillità del regno.
E che tale tolleranza dal popolo e dal clero di entrambi le due religioni, fosse ben accetta ce lo conferma un periodo di relativa tranquillità nel resto di tutta Italia.
Gli incidenti nell'arco di venticinque anni non sono in certi casi mancati, ma sempre circoscritti in alcuni territori; ovviamente Roma era quello più irrequieto, sia perchè c'era il papato, e sia perché convivevano due fazioni (l'aristocratica e la plebea) che si contrastavano fortemente soprattutto quando avvenivano le elezioni del pontefice. Ognuno voleva l'elezione del suo rappresentante.
I campioni nell'accendere la miccia nelle dispute, anche pretestuose, erano sempre gli ariani (la milizia barbara a Roma era notevole), gli ebrei (per altre ragioni), e i cristiani; quest'ultimi divisi fra l'altro in due correnti di pensiero, quella bizantina e quella cattolica.
E' dunque a Roma che scoppiavano continuamente liti violente, turbative nelle funzioni, incendio di basiliche, sinagoghe o chiese ariane. I tumulti spesso sconfinavano in vere e proprie battaglie cittadine con vittime da entrambi le parti. Lo abbiamo già letto, Teodorico si era sempre destreggiato nell'appianare questi contrasti, meritandosi anche molte lodi di saggio moderatore.
Del resto questi intralci venivano da personaggi ininfluenti, quindi le preoccupazioni erano realative. Era lui ad avere in mano lo stato, l'esercito, l'autorità.
Ma con l'editto, ora era tutto diverso. TEODORICO, ebbe la netta impressione che il mondo gli stava crollando addosso, non sapendo cosa fare, convinto che con l'editto sarebbe venuta meno anche la sua autorità, si rimette a Papa GIOVANNI per un intervento a favore di questa tolleranza che invece lui - questo voleva sottolineare- aveva sempre praticata. Ecco perchè invia proprio dei cristiani per intercedere presso l'imperatore.
Convinse così il Papa, cinque vescovi e quattro senatori a recarsi da GIUSTINO a Costantinopoli.
Abbiamo già letto lo scorso anno, che genere di complicità c'era nell'appoggiare questa nuova politica religiosa improvvisamente sortita da Costantinopoli. Teodorico era andato in collera, mandando al patibolo per tradimento presunto alcuni suoi stimati collaboratori. Che indubbiamente non agivano da soli (Oltre Boezio, quest'anno manda al patibolo anche suo suocero il senatore Simmaco).
In questo terrore seminato dalla collera di Teodorico, molti non si esposero più con i giudizi, si sottomisero al suo volere, soprattutto quelli che non erano dentro nell'ambiente del clero. Che quest'ultimo remasse contro il sovrano ostrogoto non era un mistero. La politica religiosa di Teodorico sulla penisola era sì stata tollerante, ma intanto le sue alleanze con i regni barbari iniziavano a preoccupare non poco. Ed alcuni storici giustificano i cattolici questo mettersi contro il sovrano, perché non dava a loro più nessuna garanzia. Come politicamente non le dava a Bisanzio. L'esercito in Italia era guidato da Teodorico, e lo stesso re ostrogoto aveva fatto di tutto per allearsi con gli eserciti dei regni barbari. Spesso dimenticandosi che era un delegato bizantino.
Teodorico mandò un suo esercito a dar man forte a Mundo un capo predone che dai Balcani seguitava a scendere con i suoi uomini a fare razzie a Bisanzio; il generale di Teodorico mise in fuga l'esercito bizantino che si era deciso ad attaccare il predone. Allo steso modo Teodorico si comportò quando una flotta di Anastasio volle attaccare le coste pugliesi e calabre; Teodorico schierò una sua flotta per contrastarla e metterla in fuga. Un delegato bizantino che si comportava così, con questa arrogante autonomia, e perfino con delle ostilità doveva eccome preoccupare Bisanzio!
La tesi che l'accordo (l'editto dell'espulsione degli ariani) sia stato fatto in complicità tra la chiesa Romana e Giustino viene abbastanza accreditata quando si legge dagli storici la cronaca dell'arrivo dell'ambasciata inviata da Teodorico a Bisanzio.
Papa Giovanni, all'arrivo a Costantinopoli, l'imperatore Giustino con una processione lunga 12 chilometri fuori dalle mura della città lo attese e lo ricevette in grande sfarzosa pompa. Spese quasi 300.000 solidi in elargizioni alla popolazione e per organizzare feste in suo onore, attirandosi la popolarità dei cittadini, dell'aristocrazia, del clero; tutti osannanti.
Il Papa illustrò, non sappiamo se con solerzia o con fastidio, la richiesta ambasciatoria che faceva TEODORICO; che era quella di riaccogliere nell'ambito della chiesa gli ariani che ne erano stati espulsi. Ma GIUSTINO (a parlare è sempre e comunque GIUSTINIANO ) confermò la propria intransigenza nei confronti dell'arianesimo. Alla fine gli ambasciatori lasciarono Costantinopoli senza aver cambiato proprio nulla dell'editto imperiale che quindi rimaneva in vigore in tutto l' impero. Teodorico al ritorno, avvenuto nei primi mesi del prossimo anno, infuriato se la prese con papa Giovanni; lo scaraventò in prigione. L'età, gli strapazzi del viaggio, più la galera gli furono fatali, il 18 maggio il papa moriva.
La tensione religiosa da questo momento si fa ancora più acuta. TEODORICO si scatena; ma non andrà molto lontano, come vedremo.
ANNO 524
TEODORICO - VERSO LA ROVINA
L'EDITTO ANTIARIANO DI GIUSTINO
I FRANCHI - COSA SI FA PER IL POTERE!
PERSIA - L'ELIMINAZIONE DEL "COMUNISTA"
Vecchio e malato (ha 70 anni) Teodorico è diventato diffidente con tutti i suoi collaboratori, sta attraversando un periodo di decadenza senile che lo porta a prendere decisioni tipiche di colui che ha l'impressione di essere esautorato o di essere oggetto di atti persecutori.
Ma ne aveva le ragioni, perché anche in occidente è piombato l'editto dello scorso anno di Giustino che mette al bando su tutto l' impero l'Arianesimo.
A Teodorico sembrò molto chiaro il provvedimento: prendeva di mira lui, i suoi ostrogoti, il suo governo. Cioè veniva messa in discussione tutta la sua politica religiosa in occidente. Che però come nella politica estera (i famosi matrimoni) era stata la sua sempre tollerante ma piuttosto ambigua.
Quantunque ariano aveva comunque accordato la sua protezione alla chiesa cattolica. Un atteggiamento questo -diranno i suoi denigratori- solo per conciliarsi le simpatie dei vescovi soprattutto nell'Italia settentrionale. Che a loro volta accettarono questa situazione, o perché temevano le conseguenze, o perchè attendevano con pazienza tempi migliori
E anche a Roma Teodorico più di tanto non s'ingerì nelle agitate elezioni dei pontefici; e quando lo fece, come nel 498, nella disputa fra Simmaco e Lorenzo, con una singolare risoluzione, diede ragioni ad entrambe le due fazioni, e i due furono eletti contemporaneamente. Non accontentando così nessuno, che ripresero a scannarsi l'un l'altro.
Di sinodi, concili, congressi religiosi ce ne furono a iosa, di dibattiti violenti pure, e lotte, sommosse e scontri tra le due fazioni non mancarono di insanguinare le vie e le piazze.
Ma Teodorico si destreggiava (e fu anche ammirato per questo), scantonava, consigliando solo di sistemare al meglio le dispute, e che era compito del clero porre fine ai contrasti religiosi, e non la "missione" di un soldato. Insomma sembrava dar prova di imparzialità e nello stesso tempo di fermezza. Di casi a favore dei cristiani se ne contano molti, a favore degli ebrei pure. Proprio quest'anno, a Verona, i cristiani incendiarono le sinagoghe degli ebrei; intervenne Teodorico ingiungendo ai cristiani di riedificarle a proprie spese.
Ma anche i danni inferti a un cattolico, un certo Aureliano, Teodorico intervenne per farlo rientrare in possesso quanto gli era stato sottratto. Nelle distruzioni fatte dai suoi soldati alle chiese, chiamò un vescovo a quantificare i danni e a rimborsarli.
Stabilì anche norme che le vertenze ecclesiastiche venissero riservate a giudici ecclesiastici.
Ma sulle tribù barbariche di frontiera e oltre queste, all'origine tutte ariane, seguitò ad esercitare una sorta di protettorato ariano. Che in alcuni casi fallì, nonostante i matrimoni, come nel caso dei Franchi convertiti al cristianesimo, o dei Borgundi. " Il suo obiettivo - scrive l'Anonimo- nel fare i più singolari matrimoni, era di estendere la sua sfera d'azione nelle popolazioni barbare anche con la religione, per vie indirette voleva ingraziarsi tutti i popoli". Poi, prima con i Franchi, e ora anche in quell'Italia che fino ad ora lui aveva usato una certa calcolata tolleranza di riguardo, non raccolse i frutti sperati.
Quando giunse il provvedimento di Giustino, si sentì profondamente ferito. Crollava tutta la sua opera. Ci vide un complotto, e chi anche se non palesemente l'appoggiava questo editto, lo considerò un traditore da mandare a morte. Una denuncia di Cipriano verso ALBINO incolpato di intrighi con Bisanzio, pur essendo un suo fidato collaboratore, Teodorico lo accusò di tradimento e lo fece giustiziare lasciando sconcertati un po' tutti, amici e nemici.
Che ci fosse un appoggio senatoriale e una macchinazione anche del Papa non è stato dimostrato, ma un altro patrizio SEVERINO BOEZIO, magister aofficiorum, sconvolto per la morte di Albino, si è permesso quest'anno di accusare Teodorico di assassinio con una dichiarazione quasi ostentata affermando pubblicamente "se Albino ha scritto a Costantinopoli lo ha fatto con il consenso mio e dell'intero Senato." (e se parlava così, vuol dire che si sentiva protetto - ma questa protezione poi venne a mancare)
Infatti questa audacia autoaccusatoria provoca Teodorico che fa mettere in carcere anche lui. Boezio nella sua prigionia scriverà una delle sue più belle opere (De consolatione) ma poi dopo uno sbrigativo processo viene condannato a morte in un modo perfino sadico.
Teodorico sta insomma perdendo le staffe e sta accelerando la dissoluzione del regno ostrogoto da lui fondato in Italia in un quarto di secolo.
In questa crisi cercò di trovare una via d'uscita, ma fallì anche in questo tentativo. Inviò a Costantinopoli (ne parleremo ancora il prossimo anno) una delegazione addirittura con a capo Papa Giovanni e cinque vescovi cristiani per evitare l'espulsione degli ariani alla corte di Ravenna; ma a Bisanzio era cambiata tutta la politica dei compromessi, Giustino (meglio dire Giustiniano) confermò la propria intransigenza nei confronti dell'arianesimo.
Il prossimo anno dopo il ritorno della fallimentare ambasciata Teodorico perse il controllo della situazione e di sé; preparò un editto in base al quale tutti i cristiani cattolici avrebbero dovuto essere cacciati dalle chiese il settimo giorno delle calende di settembre del 526.
Ma prima della pubblicazione dell'editto Teodorico moriva per un attacco di dissenteria.
A Costantinopoli ne furono felici. Se Giustiniano aveva già iniziato a dare una svolta alla politica imperiale, la morte di Teodorico accelerava il disfacimento di tutta la ultradecennale dominazione ostrogota, da molto tempo in Italia e a Costantinopoli tollerata, prima da Zenone poi da Anastasio.
Ma non fu semplice. L'eliminazione di un vassallo che aveva spadroneggiato, se contribuirono a sollecitare un intervento di Giustiniano in Italia, aprirono anche quel conflitto che andò poi a insanguinare l'Italia dal 536 al 553. Una caotica situazione che permise una nuova invasione di barbari, piuttosto consistente, e questa volta permanente: quella dei Longobardi.
I FRANCHI - COSA SI FA PER IL POTERE!
IN FRANCIA i quattro figli di Clodoveo, in una nuova campagna contro i Burgundi, in uno scontro rimane ucciso CLODIMIRO. Gli altri due CLOTARIO e CHILDEBERTO fanno uccidere i suoi figli la moglie e il loro seguito, evitando così la successione e si spartiscono il regno del fratello. Il regno di Orleans.
Dai generali romani hanno imparato anche questo! E non finisce qui!
L'ELIMINAZIONE DEL COMUNISTA MAZDAK
IN PERSIA, COSROE che è figlio di Re Kavadah, il sovrano che aveva preso come consigliere quel MAZDAK con dottrine comuniste che abbiamo già illustrato nel 497 (vedi), si stacca dal padre e dalla sua politica sociale. Appoggiato da tutta la borghesia terriera in fermento, che stava assistendo alla disgregazione del proprio potere oligarchico, organizza un confronto con i teologi persiani con questo rivoluzionario per capire e approfondire meglio le sue rivendicazioni.
Mazdak viene convocato a palazzo, ma prima ancora di essere ascoltato, viene subito proditoriamente ucciso. E contemporaneamente si scatena il massacro dei suoi seguaci intervenuti alla conferenza.
Si instaura una politica del terrore peggiore di prima, che riconduce nell'alveo di un'accettazione passiva delle nuove angherie. Erano state questi i motivi che avevano scatenato le ribellioni sociali di tanti poveri contadini sfruttati.
Perdenti e sfiduciati dopo aver perso il loro grande capo carismatico, quelli scampati al massacro debbono ritornare con la testa china a riprendere in silenzio i lavori sotto il potere feudale, pena la morte.
Un'idea comunista fallita nel sangue , ovviamente per aver predicato l'eguaglianza, l'equa distribuzione delle proprietà, la distribuzione delle terre incolte, migliori salari e meno sfruttamento.
Insomma un Marx in miniatura con un'ideologia molto simile.
Kavadah, quasi uscito esautorato da questa rivoluzione dello stato, governerà con moderazione nei confronti della borghesia fino al 531 (vedi), ma salito sul trono il figlio, Cosroe cambia radicalmente lo stato sasanide.
L'EDITTO ANTIARIANO DI GIUSTINO
I FRANCHI - COSA SI FA PER IL POTERE!
PERSIA - L'ELIMINAZIONE DEL "COMUNISTA"
Vecchio e malato (ha 70 anni) Teodorico è diventato diffidente con tutti i suoi collaboratori, sta attraversando un periodo di decadenza senile che lo porta a prendere decisioni tipiche di colui che ha l'impressione di essere esautorato o di essere oggetto di atti persecutori.
Ma ne aveva le ragioni, perché anche in occidente è piombato l'editto dello scorso anno di Giustino che mette al bando su tutto l' impero l'Arianesimo.
A Teodorico sembrò molto chiaro il provvedimento: prendeva di mira lui, i suoi ostrogoti, il suo governo. Cioè veniva messa in discussione tutta la sua politica religiosa in occidente. Che però come nella politica estera (i famosi matrimoni) era stata la sua sempre tollerante ma piuttosto ambigua.
Quantunque ariano aveva comunque accordato la sua protezione alla chiesa cattolica. Un atteggiamento questo -diranno i suoi denigratori- solo per conciliarsi le simpatie dei vescovi soprattutto nell'Italia settentrionale. Che a loro volta accettarono questa situazione, o perché temevano le conseguenze, o perchè attendevano con pazienza tempi migliori
E anche a Roma Teodorico più di tanto non s'ingerì nelle agitate elezioni dei pontefici; e quando lo fece, come nel 498, nella disputa fra Simmaco e Lorenzo, con una singolare risoluzione, diede ragioni ad entrambe le due fazioni, e i due furono eletti contemporaneamente. Non accontentando così nessuno, che ripresero a scannarsi l'un l'altro.
Di sinodi, concili, congressi religiosi ce ne furono a iosa, di dibattiti violenti pure, e lotte, sommosse e scontri tra le due fazioni non mancarono di insanguinare le vie e le piazze.
Ma Teodorico si destreggiava (e fu anche ammirato per questo), scantonava, consigliando solo di sistemare al meglio le dispute, e che era compito del clero porre fine ai contrasti religiosi, e non la "missione" di un soldato. Insomma sembrava dar prova di imparzialità e nello stesso tempo di fermezza. Di casi a favore dei cristiani se ne contano molti, a favore degli ebrei pure. Proprio quest'anno, a Verona, i cristiani incendiarono le sinagoghe degli ebrei; intervenne Teodorico ingiungendo ai cristiani di riedificarle a proprie spese.
Ma anche i danni inferti a un cattolico, un certo Aureliano, Teodorico intervenne per farlo rientrare in possesso quanto gli era stato sottratto. Nelle distruzioni fatte dai suoi soldati alle chiese, chiamò un vescovo a quantificare i danni e a rimborsarli.
Stabilì anche norme che le vertenze ecclesiastiche venissero riservate a giudici ecclesiastici.
Ma sulle tribù barbariche di frontiera e oltre queste, all'origine tutte ariane, seguitò ad esercitare una sorta di protettorato ariano. Che in alcuni casi fallì, nonostante i matrimoni, come nel caso dei Franchi convertiti al cristianesimo, o dei Borgundi. " Il suo obiettivo - scrive l'Anonimo- nel fare i più singolari matrimoni, era di estendere la sua sfera d'azione nelle popolazioni barbare anche con la religione, per vie indirette voleva ingraziarsi tutti i popoli". Poi, prima con i Franchi, e ora anche in quell'Italia che fino ad ora lui aveva usato una certa calcolata tolleranza di riguardo, non raccolse i frutti sperati.
Quando giunse il provvedimento di Giustino, si sentì profondamente ferito. Crollava tutta la sua opera. Ci vide un complotto, e chi anche se non palesemente l'appoggiava questo editto, lo considerò un traditore da mandare a morte. Una denuncia di Cipriano verso ALBINO incolpato di intrighi con Bisanzio, pur essendo un suo fidato collaboratore, Teodorico lo accusò di tradimento e lo fece giustiziare lasciando sconcertati un po' tutti, amici e nemici.
Che ci fosse un appoggio senatoriale e una macchinazione anche del Papa non è stato dimostrato, ma un altro patrizio SEVERINO BOEZIO, magister aofficiorum, sconvolto per la morte di Albino, si è permesso quest'anno di accusare Teodorico di assassinio con una dichiarazione quasi ostentata affermando pubblicamente "se Albino ha scritto a Costantinopoli lo ha fatto con il consenso mio e dell'intero Senato." (e se parlava così, vuol dire che si sentiva protetto - ma questa protezione poi venne a mancare)
Infatti questa audacia autoaccusatoria provoca Teodorico che fa mettere in carcere anche lui. Boezio nella sua prigionia scriverà una delle sue più belle opere (De consolatione) ma poi dopo uno sbrigativo processo viene condannato a morte in un modo perfino sadico.
Teodorico sta insomma perdendo le staffe e sta accelerando la dissoluzione del regno ostrogoto da lui fondato in Italia in un quarto di secolo.
In questa crisi cercò di trovare una via d'uscita, ma fallì anche in questo tentativo. Inviò a Costantinopoli (ne parleremo ancora il prossimo anno) una delegazione addirittura con a capo Papa Giovanni e cinque vescovi cristiani per evitare l'espulsione degli ariani alla corte di Ravenna; ma a Bisanzio era cambiata tutta la politica dei compromessi, Giustino (meglio dire Giustiniano) confermò la propria intransigenza nei confronti dell'arianesimo.
Il prossimo anno dopo il ritorno della fallimentare ambasciata Teodorico perse il controllo della situazione e di sé; preparò un editto in base al quale tutti i cristiani cattolici avrebbero dovuto essere cacciati dalle chiese il settimo giorno delle calende di settembre del 526.
Ma prima della pubblicazione dell'editto Teodorico moriva per un attacco di dissenteria.
A Costantinopoli ne furono felici. Se Giustiniano aveva già iniziato a dare una svolta alla politica imperiale, la morte di Teodorico accelerava il disfacimento di tutta la ultradecennale dominazione ostrogota, da molto tempo in Italia e a Costantinopoli tollerata, prima da Zenone poi da Anastasio.
Ma non fu semplice. L'eliminazione di un vassallo che aveva spadroneggiato, se contribuirono a sollecitare un intervento di Giustiniano in Italia, aprirono anche quel conflitto che andò poi a insanguinare l'Italia dal 536 al 553. Una caotica situazione che permise una nuova invasione di barbari, piuttosto consistente, e questa volta permanente: quella dei Longobardi.
I FRANCHI - COSA SI FA PER IL POTERE!
IN FRANCIA i quattro figli di Clodoveo, in una nuova campagna contro i Burgundi, in uno scontro rimane ucciso CLODIMIRO. Gli altri due CLOTARIO e CHILDEBERTO fanno uccidere i suoi figli la moglie e il loro seguito, evitando così la successione e si spartiscono il regno del fratello. Il regno di Orleans.
Dai generali romani hanno imparato anche questo! E non finisce qui!
L'ELIMINAZIONE DEL COMUNISTA MAZDAK
IN PERSIA, COSROE che è figlio di Re Kavadah, il sovrano che aveva preso come consigliere quel MAZDAK con dottrine comuniste che abbiamo già illustrato nel 497 (vedi), si stacca dal padre e dalla sua politica sociale. Appoggiato da tutta la borghesia terriera in fermento, che stava assistendo alla disgregazione del proprio potere oligarchico, organizza un confronto con i teologi persiani con questo rivoluzionario per capire e approfondire meglio le sue rivendicazioni.
Mazdak viene convocato a palazzo, ma prima ancora di essere ascoltato, viene subito proditoriamente ucciso. E contemporaneamente si scatena il massacro dei suoi seguaci intervenuti alla conferenza.
Si instaura una politica del terrore peggiore di prima, che riconduce nell'alveo di un'accettazione passiva delle nuove angherie. Erano state questi i motivi che avevano scatenato le ribellioni sociali di tanti poveri contadini sfruttati.
Perdenti e sfiduciati dopo aver perso il loro grande capo carismatico, quelli scampati al massacro debbono ritornare con la testa china a riprendere in silenzio i lavori sotto il potere feudale, pena la morte.
Un'idea comunista fallita nel sangue , ovviamente per aver predicato l'eguaglianza, l'equa distribuzione delle proprietà, la distribuzione delle terre incolte, migliori salari e meno sfruttamento.
Insomma un Marx in miniatura con un'ideologia molto simile.
Kavadah, quasi uscito esautorato da questa rivoluzione dello stato, governerà con moderazione nei confronti della borghesia fino al 531 (vedi), ma salito sul trono il figlio, Cosroe cambia radicalmente lo stato sasanide.
ANNO 523
I FIGLI DI CLODOVEO
ALTRO ASSALTO ALLA BORGUNDIA
Nonostante i matrimoni, nonostante le buone intenzioni, la conversione, e l'accettazione di una protezione dei Franchi, il giovane re dei Borgundi, Sigismondo, piuttosto ribelle a tutte queste imposizioni, che significa la perdita di una autonomia nel proprio regno, provoca intenzioni guerresche ai quattro fratelli Franchi, che anche se stanno architettando fra di loro di farsi fuori l'un l'altro per allargare il loro frammento di regno ereditato dal padre Clodoveo, questa volta si uniscono per sottomettere definitivamente la Borgundia. Che però sono deboli come re, ma come soldati sono una forza considerevole capace di respingere anche i Franchi.
Con varie campagne, i quattro fratelli, tentano più volte l'assalto, fin quando nel corso di uno dei tanti scontri, sconfiggono uno dei reparti guidati dal re borgundo, e catturano proprio Sigismondo. Nella fuga si era rifugiato in uno di quei monasteri che Clodoveo al concilio di Orleans aveva creato come "luogo sacri" inviolabili, quindi stabilito il diritto di dare asilo politico ai perseguitati di ogni genere.
I figli non rispettano questo diritto, irrompono nel monastero, catturano Sigismondo, e gli immergono la testa in una fontana, il tempo necessario per farlo affogare.
Ma nonostante la cattura e la morte di Sigismondo, i Franchi non hanno ancora vinto i Borgundi. A riprendere in mano l'esercito è il fratello GONDEMARO, che oltre che succedergli sul trono, con una offensiva riesce nuovamente a respingere i franchi. Dopo questa guiderà poi egregiamente i suoi uomini per altri dieci anni, e sempre a spese dei Franchi
Come vedremo nei prossimi anni, questa alleanza dei quattro fratelli franchi durerà molto poco; forse lo scopo della cooperazione militare era quello di allargare prima il regno, per poi assassinarsi a vicenda per impossessarsene.
Se in occidente la situazione è ancora quella dove spadroneggiano regni barbari vassalli più o meno di Teodorico, lo stesso Teodorico come vassallo bizantino spadroneggia in Italia. Ma a Costantinopoli ragioni politiche e religiose sotto la regia di Giustiniano (anche se gli editti sono di Giustino) stanno concorrendo a sollecitare un intervento imperiale non più disposto a tollerare in Italia nè l'ostrogoto, nè la sua politica religiosa ariana.
Esce l'editto di Giustino che mette al bando l'arianesimo in tutto l'impero.
(ne parliamo il prossimo anno)
ALTRO ASSALTO ALLA BORGUNDIA
Nonostante i matrimoni, nonostante le buone intenzioni, la conversione, e l'accettazione di una protezione dei Franchi, il giovane re dei Borgundi, Sigismondo, piuttosto ribelle a tutte queste imposizioni, che significa la perdita di una autonomia nel proprio regno, provoca intenzioni guerresche ai quattro fratelli Franchi, che anche se stanno architettando fra di loro di farsi fuori l'un l'altro per allargare il loro frammento di regno ereditato dal padre Clodoveo, questa volta si uniscono per sottomettere definitivamente la Borgundia. Che però sono deboli come re, ma come soldati sono una forza considerevole capace di respingere anche i Franchi.
Con varie campagne, i quattro fratelli, tentano più volte l'assalto, fin quando nel corso di uno dei tanti scontri, sconfiggono uno dei reparti guidati dal re borgundo, e catturano proprio Sigismondo. Nella fuga si era rifugiato in uno di quei monasteri che Clodoveo al concilio di Orleans aveva creato come "luogo sacri" inviolabili, quindi stabilito il diritto di dare asilo politico ai perseguitati di ogni genere.
I figli non rispettano questo diritto, irrompono nel monastero, catturano Sigismondo, e gli immergono la testa in una fontana, il tempo necessario per farlo affogare.
Ma nonostante la cattura e la morte di Sigismondo, i Franchi non hanno ancora vinto i Borgundi. A riprendere in mano l'esercito è il fratello GONDEMARO, che oltre che succedergli sul trono, con una offensiva riesce nuovamente a respingere i franchi. Dopo questa guiderà poi egregiamente i suoi uomini per altri dieci anni, e sempre a spese dei Franchi
Come vedremo nei prossimi anni, questa alleanza dei quattro fratelli franchi durerà molto poco; forse lo scopo della cooperazione militare era quello di allargare prima il regno, per poi assassinarsi a vicenda per impossessarsene.
Se in occidente la situazione è ancora quella dove spadroneggiano regni barbari vassalli più o meno di Teodorico, lo stesso Teodorico come vassallo bizantino spadroneggia in Italia. Ma a Costantinopoli ragioni politiche e religiose sotto la regia di Giustiniano (anche se gli editti sono di Giustino) stanno concorrendo a sollecitare un intervento imperiale non più disposto a tollerare in Italia nè l'ostrogoto, nè la sua politica religiosa ariana.
Esce l'editto di Giustino che mette al bando l'arianesimo in tutto l'impero.
(ne parliamo il prossimo anno)
ANNO 522
IN AFRICA MUORE TRASAMONDO RE DEI VANDALI
Sale sul trono dei Vandali che fu di Genserico, ILDERICO, un sovrano vandalo anomalo, con una formazione culturale tutta bizantina e non barbara. Fin da giovinetto, come era in uso allora, per far rispettare gli accordi tra Bizanzio e i Vandali, il bambino fu preso in ostaggio dai bizantini. Come era accaduto a Teodorico, quasi recluso alla corte di Costantinopoli, qui aveva studiato, qui ricevette la sua formazione culturale,
TRASAMONDO suo padre era salito sul trono nel 484, dopo la morte del figlio di Genserico, cioè Unerico, che si era rivelato appena salito sul trono prima un insofferente, poi nei successivi sei anni, fin quando visse, un accanito persecutore dei cattolici.
Trasamondo succedendogli non aveva proseguito questa suicdia politica, ma non è che aveva cambiato le idee nei confronti della religione cattolica. Non la perseguitava ma sempre insofferente ne era, abbastanza per andare d'accordo con la politica di Teodorico in Italia.
Nel giro di alleanze che Teodorico aveva impostato fra i barbari, al re vandalo Trasamondo per farselo alleato aveva dato in sposa la sorella. Quando nel 500, gli mandò in Africa AMALAFRIDA lo fece in gran pompa magna mettendo in mare una intera flotta. La fece scortare da 1000 notabili Goti, gli diede 5000 schiavi abili alle armi in dote, e in aggiunta gli diede quella Sicilia che aveva riscattato dopo aver sconfitto in Italia Odoacre.
Teodorico dandogli la sorella credeva di cementare quella costruzione che gli stava tanto a cuore: la unificazione dei barbari sotto un'unica bandiera. Dal Reno all'Africa, dalla Senna al Danubio.
Accarezzava il sogno di una grande coalizione con tutti i dinasti germanici di fede ariana, per fare un un grande impero occidentale di barbari. Con dentro Visigoti spagnoli, Vandali africani, Franchi, Germanici, Turingi, Eruli e Ostrogoti.
L' estensione di questo grande territorio che sognava, era notevole, comprendeva quasi tutta l'Europa, ad esclusione solo di Bisanzio.
Da quel matrimonio combinato, fra Vandali e Ostrogoti, era nato subito dopo Ilderico. Ma appena grandicello, come abbiamo accennato già sopra, come garanzie a certi patti, al piccolo fu riservato un soggiorno-ostaggio a Costantinopoli.
Anche se quasi recluso, studiando a corte, il ragazzo cresciuto in questo ambiente, ebbe modo di approfondire non solo la politica, le buone maniere, le istituzioni bizantine, ma anche i rapporti religiosi che da tempo dividevano i due mondi.
Cosicchè salito al trono, pur sostenendo la diffusione dell'arianesimo nell'ambito del regno vandalico, evitò di norma il ricorso a metodi violenti
Purtroppo pur con questa inclinazione alla moderatezza, pur dotato di fascino e garbo nei rapporti con i suoi ex educatori, che gli avevano insegnato l'assennatezza e il pregio di una vasta cultura, la sua nomina coincise con la salita al trono -anche se non ancora formalmente avvenuta- di Giustiniano, che inizia fin dalle prime battute a migliorare la posizione -oltre quella politica- dell'episcopato ortodosso, non solo sul suo territorio, ma anche in Africa, creando non pochi problemi al re vandalo.
Sale sul trono dei Vandali che fu di Genserico, ILDERICO, un sovrano vandalo anomalo, con una formazione culturale tutta bizantina e non barbara. Fin da giovinetto, come era in uso allora, per far rispettare gli accordi tra Bizanzio e i Vandali, il bambino fu preso in ostaggio dai bizantini. Come era accaduto a Teodorico, quasi recluso alla corte di Costantinopoli, qui aveva studiato, qui ricevette la sua formazione culturale,
TRASAMONDO suo padre era salito sul trono nel 484, dopo la morte del figlio di Genserico, cioè Unerico, che si era rivelato appena salito sul trono prima un insofferente, poi nei successivi sei anni, fin quando visse, un accanito persecutore dei cattolici.
Trasamondo succedendogli non aveva proseguito questa suicdia politica, ma non è che aveva cambiato le idee nei confronti della religione cattolica. Non la perseguitava ma sempre insofferente ne era, abbastanza per andare d'accordo con la politica di Teodorico in Italia.
Nel giro di alleanze che Teodorico aveva impostato fra i barbari, al re vandalo Trasamondo per farselo alleato aveva dato in sposa la sorella. Quando nel 500, gli mandò in Africa AMALAFRIDA lo fece in gran pompa magna mettendo in mare una intera flotta. La fece scortare da 1000 notabili Goti, gli diede 5000 schiavi abili alle armi in dote, e in aggiunta gli diede quella Sicilia che aveva riscattato dopo aver sconfitto in Italia Odoacre.
Teodorico dandogli la sorella credeva di cementare quella costruzione che gli stava tanto a cuore: la unificazione dei barbari sotto un'unica bandiera. Dal Reno all'Africa, dalla Senna al Danubio.
Accarezzava il sogno di una grande coalizione con tutti i dinasti germanici di fede ariana, per fare un un grande impero occidentale di barbari. Con dentro Visigoti spagnoli, Vandali africani, Franchi, Germanici, Turingi, Eruli e Ostrogoti.
L' estensione di questo grande territorio che sognava, era notevole, comprendeva quasi tutta l'Europa, ad esclusione solo di Bisanzio.
Da quel matrimonio combinato, fra Vandali e Ostrogoti, era nato subito dopo Ilderico. Ma appena grandicello, come abbiamo accennato già sopra, come garanzie a certi patti, al piccolo fu riservato un soggiorno-ostaggio a Costantinopoli.
Anche se quasi recluso, studiando a corte, il ragazzo cresciuto in questo ambiente, ebbe modo di approfondire non solo la politica, le buone maniere, le istituzioni bizantine, ma anche i rapporti religiosi che da tempo dividevano i due mondi.
Cosicchè salito al trono, pur sostenendo la diffusione dell'arianesimo nell'ambito del regno vandalico, evitò di norma il ricorso a metodi violenti
Purtroppo pur con questa inclinazione alla moderatezza, pur dotato di fascino e garbo nei rapporti con i suoi ex educatori, che gli avevano insegnato l'assennatezza e il pregio di una vasta cultura, la sua nomina coincise con la salita al trono -anche se non ancora formalmente avvenuta- di Giustiniano, che inizia fin dalle prime battute a migliorare la posizione -oltre quella politica- dell'episcopato ortodosso, non solo sul suo territorio, ma anche in Africa, creando non pochi problemi al re vandalo.
ANNO 521
GIUSTINIANO PATRICIUS
In questa data GIUSTINO conferisce a suo nipote il titolo di patricius e il titolo di console.
Anche se sono dello zio queste volontà formali, queste disposizioni che sembrano già una indicazione per la sua successione al nipote, l'autore del documento è lo stesso Giustiniano.
Al confusionario Giustino, inesperto in tutto ( a parte l'arte del soldato) che sapeva appena leggere, ma non scrivere, non parve vero di avere un nipote che era sceso nella capitale e gli si era presentato con un'intelligenza così matura.
A Giustino per firmare i documenti - raccontano gli storici- gli venne fabbricata un'asticella scanalata all'interno che lui con la penna percorreva (una specie di normografo).
Giustiniano non ha perso tempo dentro i suoi numerosi uffici del Palazzo, dove si aggira notte e giorno, rivolgendo attenzione a ogni cosa, anche nei dettagli. Dai funzionari lui vuole sapere tutto, conoscere ogni cosa, discutere di ogni argomento, esaminare le carte di ogni affare, così quelle diplomatiche, militari, amministrative. Ed essendo un grosso problema quello religioso, convoca a palazzo teologi delle due fazioni in lotta da anni; vuole capire.
Prende in mano subito lui l'intera amministrazione dello Stato. E' lui nell'ombra che sta già delineando il futuro del nuovo impero bizantino. Era ansioso di esercitare il potere imperiale -anche se di fatto lo esercita- e dovette anche soffrire, lui che sentiva il bisogno di far sapere a tutto il mondo, con quanto zelo si stava applicando per riportare l'impero all'antica dignità imperiale romana. Perché a questa guardava; la restaurazione del grande "Impero Romano". Il suo compito era quello di far ritornare l'impero alle antiche tradizioni dei Cesari.
Già si sentiva il successore e l'erede vivente di quegli uomini che avevano contribuito ad estendere la loro sovranità fino ai confini dei due oceani. E soffriva nel prendere coscienza che buona parte dei territori, erano caduti in mano a dei barbari ignoranti ed arroganti.
Proprio per questo suo impegno - poichè poi riuscì a ricoprire degnamente questo ruolo di restauratore- Giustiniano fu poi definito il meno bizantino dell'ultimo degli imperatori di Roma.
Insomma l'ex contadino di Skoplje (che a quanto pare sapeva già tutto della storia romana) si sta preparando come in una missione affidatagli da Dio, a riconquistare l'infallibilità attribuita alla funzione imperiale; vuole essere lui il riformatore, il legislatore; e come gli antichi Cesari vuole ritornare alla grandezza imperiale con l'uso delle leggi e il prestigio degli eserciti.
A Giustino non parve vero, il nipote ci sapeva fare. Da questo momento è lui ad essere il subordinato. E con l'assicella di legno firma, firma tutto.
In questa data GIUSTINO conferisce a suo nipote il titolo di patricius e il titolo di console.
Anche se sono dello zio queste volontà formali, queste disposizioni che sembrano già una indicazione per la sua successione al nipote, l'autore del documento è lo stesso Giustiniano.
Al confusionario Giustino, inesperto in tutto ( a parte l'arte del soldato) che sapeva appena leggere, ma non scrivere, non parve vero di avere un nipote che era sceso nella capitale e gli si era presentato con un'intelligenza così matura.
A Giustino per firmare i documenti - raccontano gli storici- gli venne fabbricata un'asticella scanalata all'interno che lui con la penna percorreva (una specie di normografo).
Giustiniano non ha perso tempo dentro i suoi numerosi uffici del Palazzo, dove si aggira notte e giorno, rivolgendo attenzione a ogni cosa, anche nei dettagli. Dai funzionari lui vuole sapere tutto, conoscere ogni cosa, discutere di ogni argomento, esaminare le carte di ogni affare, così quelle diplomatiche, militari, amministrative. Ed essendo un grosso problema quello religioso, convoca a palazzo teologi delle due fazioni in lotta da anni; vuole capire.
Prende in mano subito lui l'intera amministrazione dello Stato. E' lui nell'ombra che sta già delineando il futuro del nuovo impero bizantino. Era ansioso di esercitare il potere imperiale -anche se di fatto lo esercita- e dovette anche soffrire, lui che sentiva il bisogno di far sapere a tutto il mondo, con quanto zelo si stava applicando per riportare l'impero all'antica dignità imperiale romana. Perché a questa guardava; la restaurazione del grande "Impero Romano". Il suo compito era quello di far ritornare l'impero alle antiche tradizioni dei Cesari.
Già si sentiva il successore e l'erede vivente di quegli uomini che avevano contribuito ad estendere la loro sovranità fino ai confini dei due oceani. E soffriva nel prendere coscienza che buona parte dei territori, erano caduti in mano a dei barbari ignoranti ed arroganti.
Proprio per questo suo impegno - poichè poi riuscì a ricoprire degnamente questo ruolo di restauratore- Giustiniano fu poi definito il meno bizantino dell'ultimo degli imperatori di Roma.
Insomma l'ex contadino di Skoplje (che a quanto pare sapeva già tutto della storia romana) si sta preparando come in una missione affidatagli da Dio, a riconquistare l'infallibilità attribuita alla funzione imperiale; vuole essere lui il riformatore, il legislatore; e come gli antichi Cesari vuole ritornare alla grandezza imperiale con l'uso delle leggi e il prestigio degli eserciti.
A Giustino non parve vero, il nipote ci sapeva fare. Da questo momento è lui ad essere il subordinato. E con l'assicella di legno firma, firma tutto.
martedì 5 agosto 2014
Dies irae
Dies Irae, dies illa
solvet saeclum in favilla:
teste David cum Sybilla.
Quantus tremor est futurus,
Quando judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus.
Tuba, mirum spargens sonum
per sepulcra regionum
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet, apparebit:
nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?
Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae
ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus,
redemisti Crucem passus:
tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.
Ingemisco, tamquam reus,
culpa rubet vultus meus
supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae,
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
gere curam mei finis.
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen.
solvet saeclum in favilla:
teste David cum Sybilla.
Quantus tremor est futurus,
Quando judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus.
Tuba, mirum spargens sonum
per sepulcra regionum
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet, apparebit:
nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?
Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae
ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus,
redemisti Crucem passus:
tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.
Ingemisco, tamquam reus,
culpa rubet vultus meus
supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae,
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
gere curam mei finis.
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen.
Traduzione:
Il giorno dell'ira, quel giorno che
dissolverà il mondo terreno in cenere
come annunciato da Davide e dalla Sibilla.
Quanto terrore verrà
quando il giudice giungerà
a giudicare severamente ogni cosa.
La tromba diffondendo un suono mirabile
tra i sepolcri del mondo
spingerà tutti davanti al trono.
La Morte e la Natura si stupiranno
quando risorgerà ogni creatura
per rispondere al giudice.
Sarà presentato il libro scritto
nel quale è contenuto tutto,
dal quale si giudicherà il mondo.
E dunque quando il giudice si siederà,
ogni cosa nascosta sarà svelata,
niente rimarrà invendicato.
In quel momento che potrò dire io, misero,
chi chiamerò a difendermi,
quando a malapena il giusto potrà dirsi al sicuro?
Re di tremendo potere,
tu che salvi per grazia chi è da salvare,
salva me, fonte di pietà.
Ricorda, o pio Gesù,
che io sono la causa del tuo viaggio;
non lasciare che quel giorno io sia perduto.
Cercandomi ti sedesti stanco,
mi hai redento con il supplizio della Croce:
che tanto sforzo non sia vano!
Giusto giudice di retribuzione,
concedi il dono del perdono
prima del giorno della resa dei conti.
Comincio a gemere come un colpevole,
per la colpa è rosso il mio volto;
risparmia chi ti supplica, o Dio.
Tu che perdonasti Maria di Magdala,
tu che esaudisti il buon ladrone,
anche a me hai dato speranza.
Le mie preghiere non sono degne;
ma tu, buon Dio, con benignità fa'
che io non sia arso dal fuoco eterno.
Assicurami un posto fra le pecorelle,
e tienimi lontano dai caproni,
ponendomi alla tua destra.
Una volta smascherati i malvagi,
condannati alle fiamme feroci,
chiamami tra i benedetti.
Prego supplice e in ginocchio,
il cuore contrito, come ridotto a cenere,
prenditi cura del mio destino.
Giorno di lacrime, quello,
quando risorgerà dalla cenere
Il peccatore per essere giudicato.
perdonalo, o Dio:
Pio Signore Gesù,
dona a loro la pace. Amen.
lunedì 4 agosto 2014
ANNO 520
IL BUDDHISMO IN CINA
LA "SAGGEZZA" ORIENTALE
E' di quest' anno la prima testimonianza della grande arte cinese che lascia ai posteri la prima scultura del gruppo dorato di BUDDHA.
E lo stesso anno anche l'arrivo in Cina, proveniente dall'India, di BODHIDHARMA, il primo patriarca della scuola buddhista ch'an (meglio conosciuta con il nome giapponese ZEN).
L' introduzione di questa dottrina in Cina si dimostrò determinante per lo sviluppo della "saggezza" ("religione", "filosofia") cinese, perché entrambe le scuole di Confucio, Buddha, e Lao Tse fino al XVIII secolo rimasero in buona armonia, l'una vicina all'altra.
Per tutto questo tempo si arrivò perfino a dimostrare che le tre scuole sono nella loro sintesi concettuale una cosa sola. Tutte e tre nelle loro manifestazioni "religiose" lasciarono sussistere i culti di "religioni" più antiche facendo di queste "religioni" filosofiche una "religione" universale. Nessuna delle tre non ha mai richiesto ai suoi seguaci un'adesione e una fede esclusiva, perchè considera valide tutte le altre "religioni" e non conosce l' intolleranza (perchè non sono religioni come le intende un occidentale).
IL SIDDHARTA, BUDDHA dal punto di vista storico, della sua gioventù non si sa quasi nulla; si trasmisero sia i fatti leggendari che i suoi insegnamenti solo oralmente, tramandati nei vari dialetti.
La tradizione scritta non venne fissata se non dopo un secolo dopo la morte.
In questi anni 500 d.C. abbiamo però il primo "concilio" di Vaisòli dove si possiedono informazioni attendibili. I discepoli monaci convocati in questo luogo, nella loro lunga assemblea iniziarono a fissare i canoni del Buddhismo. Non che prima non esistessero.
Per intero è stato conservato fino ai nostri giorni il Tipitaka composto in dialetto pali verso il 100 a.C. Di canoni ne nacquero - prima del concilio di Vaisòli- anche altri che introdussero modifiche e interpolazioni che poi dettero vita a numerose altre scuole (come il nostro Cristianesimo che ancora oggi di correnti ne ha 5, e Chiese diverse 56; l'Ebrea, 3 correnti, 12 tribù; Musulmana, 3 correnti 65 movimenti).
Fondamentalmente però i concetti universali di questi nuovi canoni del buddhismo, di cui stiamo parlando, se andiamo alla radice sono gli stessi, e che oggi possiamo semplificare chiamandola nè filosofia nè religione (due termini che in Oriente hanno un significato completamente diverso da quello occidentale ) ma Saggezza Orientale, che ha suscitato in occidente sempre un interesse molto generico e sempre con limitate prospettive storiografiche.
Infatti anche i più preparati culturalmente si trovano in imbarazzo se devono elencare i maggiori filosofi orientali. Citano i soliti Confucio, Buddha e Lao Tsè, ma oltre non vanno, nè vanno alle radici. Sarebbe come se per capire la nostra filosofia Occidentale un cinese conoscesse solo Platone, Aristotele e Socrate. Converrebbero tutti che a un estraneo non è sufficiente per capire l'Occidente, perchè l'Occidente non è rimasto fermo ai tre filosofi greci anche se messi insieme. La nostra civiltà occidentale e medio orientale di questi ultimi 3000 anni, fino ai nostri giorni, è un insieme di filosofia e religioni di 3000 anni!
Altrettanto la stessa "saggezza" ("filosofia", "religione") Orientale (anch'essa di 3000 anni) è molto più complessa nel suo insieme che non quella -singola o le tre messe insieme- di Confucio, Lao Tse e Buddha. Quella precedente, le tre citate, e quella successiva hanno come ispirazione la stessa antica "scuola" (del resto anche la Cristiana, Ebrea e Maomettana (pur così diverse) si ispirarono tutte al Patriarca ABRAMO prendendo strade diverse, e creando dottrine e dogmi diversi; correnti diverse nelle stesse dottrine e negli stessi dogmi, tanto da arrivare a oltre un centinaio di dogmi che partono da un unico ceppo. Ognuna ne ha fatta una personale. Quella che gli faceva comodo!).
Non pretendo io di colmare quelle lacune storiografiche, ma solo stimolare il lettore a trovare una traccia che possa portare ad approfondire le dottrine Orientali, che sono banalmente molto spesso nazionalpopolarizzate per scopi che non hanno nulla a che vedere con il tema che stiamo trattando. Uno dei capostipiti l' ho già citato nel 28 d.C. quando ho accennato a quel WANG CH'UNG che in quasi tutti i testi o dizionari occidentali è quasi sconosciuto, mentre nella "filosofia" cinese occupa interi capitoli ed è considerato il più grande pensatore della scuola antica, quello che ha attinto alle radici primordiali dell'umanità ancora sgombra di una morale di comodo impostata e ratificata con leggi, e via via dai governanti di turno applicate.
Affermava che con l'avvento della società moderna organizzata, basata sul potere di questo o quell'imperatore, gli ordinamenti, le leggi, le istituzioni, gli insegnamenti, le regole di comportamento, la morale, create da loro (e per loro comodo) hanno stravolto l'ordine naturale delle cose e della società umana. Quell'ordine antico dove "c'erano" i segni di una manifestazione biologica universale alle quali si deve guardare con una spontanea commozione naturalistica e una prospettiva antropocentrica.
(E Wang Ch'ung non aveva visto ancora i nostri due ultimi secoli! il capitalismo, le multinazionali, i trust, i capi degli imperi monopolistici, l'informazione globalizzata per darci "ordini" e "morali" che spesso sono vere scemenze)
Il Buddhismo vuole liberare l'uomo dal samsòra, ossia dal circolo delle esistenze: perche' la maledizione di ogni esistenza è la sua caducità. L' "io" personale, insieme a ciò che noi chiamiamo l'anima, si trova coinvolto in questo processo. In termini metaforici si potrebbe dire che come guardando un film si ha la impressione di una continuità per il succedersi ininterrotto delle immagini staccate, benchè una vera unità non esista, del pari l'incessante susseguirsi di processi istantanei della coscienza fa nascere l'illusione di un "io" nascente.
Ma il Buddhismo non nega soltanto un'anima sostanziale; esso ritiene che gli stessi dei siamo soggetti alla caducità e alla rinascita. Sembrerebbe dunque che esso è un ateismo, e ci si è chiesti appunto se si può chiamarla una religione. Non solo, ma potrebbe conferire all'etica buddhista qualcosa di freddo e una certa passività , ad un "uscire dal mondo", e in effetti all'origine era come una religione monastica occidentale, una comunità che si poteva definire un Ordine, e solo in seguito abbracciò una più vasta cerchia di laici, i quali bastava loro di pronunciarsi davanti a un monaco la formula di "prendo rifugio nel Buddha" per esservi ammesso. (ci si sposa con l'io più che con un dio).
Per tutto il resto questo laico poteva continuare la sua vita e mantenere le sue occupazioni nel mondo, senza un qualsiasi controllo ecclesiastico; mettendo in pratica quel che della morale buddhista è realizzabile nella sua particolare esistenza. I precetti di questa morale sarebbe lungo elencarli ma rispecchiano quella che è l'etica umana fin da quando la presa di coscienza nel danneggiare un altro ha cominciato a metterci a disagio con noi stessi, quando identificandoci nell'altro capivamo cosa era male cosa era bene, e che brevemente tali concetti fondamentali si possono elencare come 1° non uccidere alcun essere vivente; 2° non appropriarsi dei beni altrui; 3° non toccare la donna degli altri; 4° non mentire. Ed era una conseguenza che - per andare nella "retta via" - comportavano l'esclusione di quelle professioni che provocavano dolore agli altri: come quella del soldato, del cacciatore, del pescatore, del macellaio, perchè implicano l'uccisione di esseri viventi.
Si vorrebbe anche nella vita ascetica del buddhista metterla in parallelo al nostro stoicismo, ma se andiamo alle origini delle stesse religioni occidentali, inizialmente a questo stoicismo, al dolore, alla sofferenza, erano proprio infarcite le prime dottrine, erano le forme per arrivare a meritarsi con l'uscita dal mondo, col cercare la sofferenza e il dolore un premio divino. Ecco dunque le punizioni corporali, le autoflagellazioni, il martirio, la morte invocata. Cosa che invece il buddhismo non contempla proprio perchè la morte conduce a una nuova nascita e non libera l'uomo dall' inesorabile destino della trasmigrazione. (l'Eterno Ritorno- Nietszchiano)
L'incontro e lo scontro del buddhismo con l' occidente, ha poi provocato all' inizio del sec.XIX e XX, un rinnovamento interno che in parte si ricollega ad antichi movimenti riformistici, e in parte ha assunto in maggiore o minore misura categorie di pensiero e strutture organizzative tipiche dell'occidente. Questo secondo movimento, cui presero parte anche i buddhisti occidentali, è stato chiamato neobuddhismo o buddhismo modernistico. Uno dei tratti che lo caratterizza è la ricezione delle scienze occidentali; l'altro è l'accentuazione (contrapposta al pensiero cristiano che resiste a oltranza) del carattere scientifico del pensiero buddhista e della sua fondabilità razionale.
Le tendenze socialrivoluzionarie del buddhismo modernista hanno portato in alcuni paesi a un'unione del buddhismo col marxismo. Citiamo Marx e Nietszche, e sembra paradossale che i due maggiori combattenti contro le religioni, nelle loro riflessioni filosofiche mettono la questione religiosa sempre al centro dei loro pensieri e arrivano a certe riflessioni diametralmente opposte. Il primo afferma che "la religione è un' invenzione dei forti per opprimere i deboli" (Marx era di origine Ebrea) ; mentre l'altro che "è un invenzione dei deboli per frenare i forti".
Entrambi in Oriente tali due riflessione sarebbero prive di sostanza e ritornando a leggere WANG CH'UNG nell'anno 28 di questa cronologia, ci si accorge che dalle sue poche righe voleva dire tutto questo e ben altro. Attingendo all'antichità, alla arcaica coscienza, spazzava via dalla sua dottrina proprio quei poteri (politici,religiosi), spazzava via la contaminazione del potere umano sulle nostre coscienze, sulla nostra morale, e additava solo la naturale biologica universale morale etica esistenziale nata con l'uomo stesso, sentita nell'armonia dell'ordine cosmico degli esseri viventi senza nessuna gerarchizzazione fabbricata a tavolino di qualche "palazzo" o in qualche "concilio".
Se noi ammettiamo invece che questa gerarchizzazione esiste e deve esistere, quando siamo deboli prepariamoci sempre a chinare la testa, e non lamentiamoci se si è perdenti. Ma attenzione nulla è più deleterio quando ci si fa soffocare dalla rassegnazione, con questa non si va da nessuna parte; prima di iniziare già siamo soccombenti, poco più che vegetali.
Si può anche prendere coscienza che alla gara che partecipiamo si può anche non vincere, ma se si ha anche coscienza che si è perso solo una gara e non tutte, si può continuare a gareggiare, insegnando se non altro a chi ci sta vicino (al nuovo discepolo) come ci si prepara a vincere, quali sono gli errori da non fare, e dov'è il punto di arrivo. E se abbiamo contribuito a far questo, qualcosa abbiamo vinto anche noi.
Significativa è quella storiella di quel cinese che avendo il suo povero orto in una valle in mezzo a due montagne, dove non arrivava mai il Sole, con una piccola pala incominciò a scavare la montagna che gli stava davanti con l'intenzione di liberarsi di quell'ostacolo e far crescere bellissimi frutti e saporite verdure; un occidentale fermandosi e osservando questa ciclopica operazione si affrettò a dire facendo i suoi calcoli che era inutile, che gli occorrevano almeno 130 anni prima di spianarla del tutto, e che lui il Sole non l'avrebbe di sicuro mai visto, -si lo so, disse il cinese- e allora perché lo fa? - perchè così mio figlio vedrà l'opera già iniziata e continuerà, poi suo figlio farà altrettanto con il suo esempio, infine come ha detto lei fra 130 anni i miei nipoti mangeranno delle ottime verdure e vedranno il sole entrare dalle finestre, e a lei tutto questo le sembra inutile?"
E pensare che se noi non abbiamo la Ferrari e la Nutella subito, ci sembra che "non è vita questa". La gerarchizzazione ci ha portato anche a questo: sappiamo quanto vale la vita eppure ascoltiamo il saccente di turno che ci dice lui quando vale la pena di viverla. Insomma che il "nostro mondo" debba per forza essere uguale al suo.
LA "SAGGEZZA" ORIENTALE
E' di quest' anno la prima testimonianza della grande arte cinese che lascia ai posteri la prima scultura del gruppo dorato di BUDDHA.
E lo stesso anno anche l'arrivo in Cina, proveniente dall'India, di BODHIDHARMA, il primo patriarca della scuola buddhista ch'an (meglio conosciuta con il nome giapponese ZEN).
L' introduzione di questa dottrina in Cina si dimostrò determinante per lo sviluppo della "saggezza" ("religione", "filosofia") cinese, perché entrambe le scuole di Confucio, Buddha, e Lao Tse fino al XVIII secolo rimasero in buona armonia, l'una vicina all'altra.
Per tutto questo tempo si arrivò perfino a dimostrare che le tre scuole sono nella loro sintesi concettuale una cosa sola. Tutte e tre nelle loro manifestazioni "religiose" lasciarono sussistere i culti di "religioni" più antiche facendo di queste "religioni" filosofiche una "religione" universale. Nessuna delle tre non ha mai richiesto ai suoi seguaci un'adesione e una fede esclusiva, perchè considera valide tutte le altre "religioni" e non conosce l' intolleranza (perchè non sono religioni come le intende un occidentale).
IL SIDDHARTA, BUDDHA dal punto di vista storico, della sua gioventù non si sa quasi nulla; si trasmisero sia i fatti leggendari che i suoi insegnamenti solo oralmente, tramandati nei vari dialetti.
La tradizione scritta non venne fissata se non dopo un secolo dopo la morte.
In questi anni 500 d.C. abbiamo però il primo "concilio" di Vaisòli dove si possiedono informazioni attendibili. I discepoli monaci convocati in questo luogo, nella loro lunga assemblea iniziarono a fissare i canoni del Buddhismo. Non che prima non esistessero.
Per intero è stato conservato fino ai nostri giorni il Tipitaka composto in dialetto pali verso il 100 a.C. Di canoni ne nacquero - prima del concilio di Vaisòli- anche altri che introdussero modifiche e interpolazioni che poi dettero vita a numerose altre scuole (come il nostro Cristianesimo che ancora oggi di correnti ne ha 5, e Chiese diverse 56; l'Ebrea, 3 correnti, 12 tribù; Musulmana, 3 correnti 65 movimenti).
Fondamentalmente però i concetti universali di questi nuovi canoni del buddhismo, di cui stiamo parlando, se andiamo alla radice sono gli stessi, e che oggi possiamo semplificare chiamandola nè filosofia nè religione (due termini che in Oriente hanno un significato completamente diverso da quello occidentale ) ma Saggezza Orientale, che ha suscitato in occidente sempre un interesse molto generico e sempre con limitate prospettive storiografiche.
Infatti anche i più preparati culturalmente si trovano in imbarazzo se devono elencare i maggiori filosofi orientali. Citano i soliti Confucio, Buddha e Lao Tsè, ma oltre non vanno, nè vanno alle radici. Sarebbe come se per capire la nostra filosofia Occidentale un cinese conoscesse solo Platone, Aristotele e Socrate. Converrebbero tutti che a un estraneo non è sufficiente per capire l'Occidente, perchè l'Occidente non è rimasto fermo ai tre filosofi greci anche se messi insieme. La nostra civiltà occidentale e medio orientale di questi ultimi 3000 anni, fino ai nostri giorni, è un insieme di filosofia e religioni di 3000 anni!
Altrettanto la stessa "saggezza" ("filosofia", "religione") Orientale (anch'essa di 3000 anni) è molto più complessa nel suo insieme che non quella -singola o le tre messe insieme- di Confucio, Lao Tse e Buddha. Quella precedente, le tre citate, e quella successiva hanno come ispirazione la stessa antica "scuola" (del resto anche la Cristiana, Ebrea e Maomettana (pur così diverse) si ispirarono tutte al Patriarca ABRAMO prendendo strade diverse, e creando dottrine e dogmi diversi; correnti diverse nelle stesse dottrine e negli stessi dogmi, tanto da arrivare a oltre un centinaio di dogmi che partono da un unico ceppo. Ognuna ne ha fatta una personale. Quella che gli faceva comodo!).
Non pretendo io di colmare quelle lacune storiografiche, ma solo stimolare il lettore a trovare una traccia che possa portare ad approfondire le dottrine Orientali, che sono banalmente molto spesso nazionalpopolarizzate per scopi che non hanno nulla a che vedere con il tema che stiamo trattando. Uno dei capostipiti l' ho già citato nel 28 d.C. quando ho accennato a quel WANG CH'UNG che in quasi tutti i testi o dizionari occidentali è quasi sconosciuto, mentre nella "filosofia" cinese occupa interi capitoli ed è considerato il più grande pensatore della scuola antica, quello che ha attinto alle radici primordiali dell'umanità ancora sgombra di una morale di comodo impostata e ratificata con leggi, e via via dai governanti di turno applicate.
Affermava che con l'avvento della società moderna organizzata, basata sul potere di questo o quell'imperatore, gli ordinamenti, le leggi, le istituzioni, gli insegnamenti, le regole di comportamento, la morale, create da loro (e per loro comodo) hanno stravolto l'ordine naturale delle cose e della società umana. Quell'ordine antico dove "c'erano" i segni di una manifestazione biologica universale alle quali si deve guardare con una spontanea commozione naturalistica e una prospettiva antropocentrica.
(E Wang Ch'ung non aveva visto ancora i nostri due ultimi secoli! il capitalismo, le multinazionali, i trust, i capi degli imperi monopolistici, l'informazione globalizzata per darci "ordini" e "morali" che spesso sono vere scemenze)
Il Buddhismo vuole liberare l'uomo dal samsòra, ossia dal circolo delle esistenze: perche' la maledizione di ogni esistenza è la sua caducità. L' "io" personale, insieme a ciò che noi chiamiamo l'anima, si trova coinvolto in questo processo. In termini metaforici si potrebbe dire che come guardando un film si ha la impressione di una continuità per il succedersi ininterrotto delle immagini staccate, benchè una vera unità non esista, del pari l'incessante susseguirsi di processi istantanei della coscienza fa nascere l'illusione di un "io" nascente.
Ma il Buddhismo non nega soltanto un'anima sostanziale; esso ritiene che gli stessi dei siamo soggetti alla caducità e alla rinascita. Sembrerebbe dunque che esso è un ateismo, e ci si è chiesti appunto se si può chiamarla una religione. Non solo, ma potrebbe conferire all'etica buddhista qualcosa di freddo e una certa passività , ad un "uscire dal mondo", e in effetti all'origine era come una religione monastica occidentale, una comunità che si poteva definire un Ordine, e solo in seguito abbracciò una più vasta cerchia di laici, i quali bastava loro di pronunciarsi davanti a un monaco la formula di "prendo rifugio nel Buddha" per esservi ammesso. (ci si sposa con l'io più che con un dio).
Per tutto il resto questo laico poteva continuare la sua vita e mantenere le sue occupazioni nel mondo, senza un qualsiasi controllo ecclesiastico; mettendo in pratica quel che della morale buddhista è realizzabile nella sua particolare esistenza. I precetti di questa morale sarebbe lungo elencarli ma rispecchiano quella che è l'etica umana fin da quando la presa di coscienza nel danneggiare un altro ha cominciato a metterci a disagio con noi stessi, quando identificandoci nell'altro capivamo cosa era male cosa era bene, e che brevemente tali concetti fondamentali si possono elencare come 1° non uccidere alcun essere vivente; 2° non appropriarsi dei beni altrui; 3° non toccare la donna degli altri; 4° non mentire. Ed era una conseguenza che - per andare nella "retta via" - comportavano l'esclusione di quelle professioni che provocavano dolore agli altri: come quella del soldato, del cacciatore, del pescatore, del macellaio, perchè implicano l'uccisione di esseri viventi.
Si vorrebbe anche nella vita ascetica del buddhista metterla in parallelo al nostro stoicismo, ma se andiamo alle origini delle stesse religioni occidentali, inizialmente a questo stoicismo, al dolore, alla sofferenza, erano proprio infarcite le prime dottrine, erano le forme per arrivare a meritarsi con l'uscita dal mondo, col cercare la sofferenza e il dolore un premio divino. Ecco dunque le punizioni corporali, le autoflagellazioni, il martirio, la morte invocata. Cosa che invece il buddhismo non contempla proprio perchè la morte conduce a una nuova nascita e non libera l'uomo dall' inesorabile destino della trasmigrazione. (l'Eterno Ritorno- Nietszchiano)
L'incontro e lo scontro del buddhismo con l' occidente, ha poi provocato all' inizio del sec.XIX e XX, un rinnovamento interno che in parte si ricollega ad antichi movimenti riformistici, e in parte ha assunto in maggiore o minore misura categorie di pensiero e strutture organizzative tipiche dell'occidente. Questo secondo movimento, cui presero parte anche i buddhisti occidentali, è stato chiamato neobuddhismo o buddhismo modernistico. Uno dei tratti che lo caratterizza è la ricezione delle scienze occidentali; l'altro è l'accentuazione (contrapposta al pensiero cristiano che resiste a oltranza) del carattere scientifico del pensiero buddhista e della sua fondabilità razionale.
Le tendenze socialrivoluzionarie del buddhismo modernista hanno portato in alcuni paesi a un'unione del buddhismo col marxismo. Citiamo Marx e Nietszche, e sembra paradossale che i due maggiori combattenti contro le religioni, nelle loro riflessioni filosofiche mettono la questione religiosa sempre al centro dei loro pensieri e arrivano a certe riflessioni diametralmente opposte. Il primo afferma che "la religione è un' invenzione dei forti per opprimere i deboli" (Marx era di origine Ebrea) ; mentre l'altro che "è un invenzione dei deboli per frenare i forti".
Entrambi in Oriente tali due riflessione sarebbero prive di sostanza e ritornando a leggere WANG CH'UNG nell'anno 28 di questa cronologia, ci si accorge che dalle sue poche righe voleva dire tutto questo e ben altro. Attingendo all'antichità, alla arcaica coscienza, spazzava via dalla sua dottrina proprio quei poteri (politici,religiosi), spazzava via la contaminazione del potere umano sulle nostre coscienze, sulla nostra morale, e additava solo la naturale biologica universale morale etica esistenziale nata con l'uomo stesso, sentita nell'armonia dell'ordine cosmico degli esseri viventi senza nessuna gerarchizzazione fabbricata a tavolino di qualche "palazzo" o in qualche "concilio".
Se noi ammettiamo invece che questa gerarchizzazione esiste e deve esistere, quando siamo deboli prepariamoci sempre a chinare la testa, e non lamentiamoci se si è perdenti. Ma attenzione nulla è più deleterio quando ci si fa soffocare dalla rassegnazione, con questa non si va da nessuna parte; prima di iniziare già siamo soccombenti, poco più che vegetali.
Si può anche prendere coscienza che alla gara che partecipiamo si può anche non vincere, ma se si ha anche coscienza che si è perso solo una gara e non tutte, si può continuare a gareggiare, insegnando se non altro a chi ci sta vicino (al nuovo discepolo) come ci si prepara a vincere, quali sono gli errori da non fare, e dov'è il punto di arrivo. E se abbiamo contribuito a far questo, qualcosa abbiamo vinto anche noi.
Significativa è quella storiella di quel cinese che avendo il suo povero orto in una valle in mezzo a due montagne, dove non arrivava mai il Sole, con una piccola pala incominciò a scavare la montagna che gli stava davanti con l'intenzione di liberarsi di quell'ostacolo e far crescere bellissimi frutti e saporite verdure; un occidentale fermandosi e osservando questa ciclopica operazione si affrettò a dire facendo i suoi calcoli che era inutile, che gli occorrevano almeno 130 anni prima di spianarla del tutto, e che lui il Sole non l'avrebbe di sicuro mai visto, -si lo so, disse il cinese- e allora perché lo fa? - perchè così mio figlio vedrà l'opera già iniziata e continuerà, poi suo figlio farà altrettanto con il suo esempio, infine come ha detto lei fra 130 anni i miei nipoti mangeranno delle ottime verdure e vedranno il sole entrare dalle finestre, e a lei tutto questo le sembra inutile?"
E pensare che se noi non abbiamo la Ferrari e la Nutella subito, ci sembra che "non è vita questa". La gerarchizzazione ci ha portato anche a questo: sappiamo quanto vale la vita eppure ascoltiamo il saccente di turno che ci dice lui quando vale la pena di viverla. Insomma che il "nostro mondo" debba per forza essere uguale al suo.
ANNO 519
L'IMPERATORE GIUSTINO E IL NIPOTE
GIUSTINIANO - DAVANTI A UNA CARRIERA
Nominato dunque dal Senato, il settantenne nuovo imperatore Giustino, è sicuramente soddisfatto per essere arrivato improvvisamente così in alto, ma è anche frastornato. Il compito che l'aspetta non è il solito, quello di guidare la guardia imperiale, ma ci sono - e lui le conosce bene per averle vissute dall'esterno- le mille incombenze; e molte di queste non sono all'altezza della sua portata. Come quelle religiose (ultimamente piuttosto critiche), come quelle politiche (i rapporti con l'occidente), o come quelle amministrative-economiche (con un impero quasi alla fame).
Come abbiamo anticipato lo scorso anno, a Giustino gli occorreva avere al suo fianco un aiuto, un consigliere, un assistente, un collaboratore giovane. Ma di chi poteva fidarsi lui, che sapeva benissimo quanto torbido era l'ambiente di corte, quello senatoriale, quello clericale e quello militare. Tutti con la vocazione a fare congiure, quando volevano, e come volevano.
Unica alternativa era quella di scegliersi un uomo fidato, preso dall'esterno. E chi meglio di un parente. Magari quel nipote che viveva a Skoplje. Quando era partito nel suo infido paese in mezzo ai sassi, aveva lasciato una sorella, che aveva un figlio, gli aveva dato perfino il suo nome.
Questo nipote si chiamava appunto GIUSTINIANO. Di che cosa si occupava a Skopje non si sa. Sappiamo solo che quando raccolse il messaggio di suo zio e scese a Costantinopoli a dargli una mano, aveva già 36 anni.
Sappiamo che faceva anche lui il contadino, ma la sua cultura ci sembra impossibile - per quanto lo zio gli mise appena arrivato subito a disposizione i migliori maestri e le migliori menti di Costantinopoli - sia riuscito a costruirsela in pochi anni.
Infatti quando arriviamo al 527 (fra otto anni) lo troviamo che governa già con vari titoli a nome dello zio. Dopo la morte ne diventa il successore naturale, ma sappiamo pure che da questo 519 (cioè appena arrivato) in pratica pur nell'ombra è già lui a governare a pieno titolo.
E governerà fino all'anno 565, quando morirà a 83 anni. Sul trono (virtuale e reale) quindi per ben 46 anni.
Per come governò, gli storici si sono tutti sbizzarriti, e quasi equamente si sono divisi nel giudicare una metà solo le opere buone e l'altra metà quelle cattive. Nelle loro narrazione ci sono adulazioni ma ci sono le smaccate invettive. Quindi un quadro contraddittorio mai visto in una biografia di un imperatore, di un uomo che in ogni caso ha lasciato un impronta profondissima nel mondo del VI secolo.
Come aspetto fisico, a San Vitale a Ravenna si conserva un ritratto in mosaico che ce lo mostra nei suoi lineamenti. Per quanto invece riguarda doti, capacità e carattere, si possono raccogliere solo in quelle biografie fatte dagli storici suoi contemporanei che nel lungo arco di tempo si sono avvicendati a fare o i panegirici o le critiche.
Nelle qualità caratteriale molti lodano la sua semplicità del suo comportamento, la cordialità del conversare, l'autocontrollo esercitato sul suo temperamento violento e, soprattutto, esaltano la passione per il lavoro che era uno dei suoi tratti più caratteristici; non per nulla un cortigiano lo soprannominò l'"Imperatore insonne ". Si alzava presto e si coricava tardi; pretendeva di conoscere tutto, voleva tutto esaminare per poi con imparzialità e senza superficialità poter decidere con giudizio sereno e con la sua coscienza a posto. Mettendo in questo compito un grande amore per l'ordine, una vera preoccupazione di amministrare bene ogni cosa nei minimi dettagli. Il futuro estensore del "codice" fin dalle prime battute volle diventare "giudice" di se stesso.
Insomma voleva essere all'altezza di svolgere il compito di sovrano nel modo migliore. Aveva un desiderio: di essere contemporaneamente come gli antichi Cesari romani, essere un legislatore e un conquistatore, rifare l'impero da capo con le leggi e se necessario anche con le armi. In più volle diventare come Costantino il campione della religione e capo supremo della chiesa.
E su questa iniziò ad interessarsi in maniera maniacale, leggendo tutto ciò che c'era di meglio e che allora esisteva, facendosi una cultura impressionante di teologia, da poter parlare da pari a pari con vescovi e prelati su questioni da secoli problematiche, irti di ostacoli, cogliendone l'essenziale, e che poi con una oratoria eccezionale esponeva con semplicità sconcertante, riuscendo a calamitare su di sé le attenzioni di tutti.
Per i difetti invece, facciamo per il momento silenzio, alcuni li scopriremo percorrendo anno per anno e fino in fondo, la sua lunga carriera; in base agli storici suoi contemporanei che li hanno evidenziati i suoi limiti, le sue lacune o i suoi errori, chi più chi meno, ognuno sarà poi libero di esprimere un suo giudizio positivo o negativo.
GIUSTINIANO - DAVANTI A UNA CARRIERA
Nominato dunque dal Senato, il settantenne nuovo imperatore Giustino, è sicuramente soddisfatto per essere arrivato improvvisamente così in alto, ma è anche frastornato. Il compito che l'aspetta non è il solito, quello di guidare la guardia imperiale, ma ci sono - e lui le conosce bene per averle vissute dall'esterno- le mille incombenze; e molte di queste non sono all'altezza della sua portata. Come quelle religiose (ultimamente piuttosto critiche), come quelle politiche (i rapporti con l'occidente), o come quelle amministrative-economiche (con un impero quasi alla fame).
Come abbiamo anticipato lo scorso anno, a Giustino gli occorreva avere al suo fianco un aiuto, un consigliere, un assistente, un collaboratore giovane. Ma di chi poteva fidarsi lui, che sapeva benissimo quanto torbido era l'ambiente di corte, quello senatoriale, quello clericale e quello militare. Tutti con la vocazione a fare congiure, quando volevano, e come volevano.
Unica alternativa era quella di scegliersi un uomo fidato, preso dall'esterno. E chi meglio di un parente. Magari quel nipote che viveva a Skoplje. Quando era partito nel suo infido paese in mezzo ai sassi, aveva lasciato una sorella, che aveva un figlio, gli aveva dato perfino il suo nome.
Questo nipote si chiamava appunto GIUSTINIANO. Di che cosa si occupava a Skopje non si sa. Sappiamo solo che quando raccolse il messaggio di suo zio e scese a Costantinopoli a dargli una mano, aveva già 36 anni.
Sappiamo che faceva anche lui il contadino, ma la sua cultura ci sembra impossibile - per quanto lo zio gli mise appena arrivato subito a disposizione i migliori maestri e le migliori menti di Costantinopoli - sia riuscito a costruirsela in pochi anni.
Infatti quando arriviamo al 527 (fra otto anni) lo troviamo che governa già con vari titoli a nome dello zio. Dopo la morte ne diventa il successore naturale, ma sappiamo pure che da questo 519 (cioè appena arrivato) in pratica pur nell'ombra è già lui a governare a pieno titolo.
E governerà fino all'anno 565, quando morirà a 83 anni. Sul trono (virtuale e reale) quindi per ben 46 anni.
Per come governò, gli storici si sono tutti sbizzarriti, e quasi equamente si sono divisi nel giudicare una metà solo le opere buone e l'altra metà quelle cattive. Nelle loro narrazione ci sono adulazioni ma ci sono le smaccate invettive. Quindi un quadro contraddittorio mai visto in una biografia di un imperatore, di un uomo che in ogni caso ha lasciato un impronta profondissima nel mondo del VI secolo.
Come aspetto fisico, a San Vitale a Ravenna si conserva un ritratto in mosaico che ce lo mostra nei suoi lineamenti. Per quanto invece riguarda doti, capacità e carattere, si possono raccogliere solo in quelle biografie fatte dagli storici suoi contemporanei che nel lungo arco di tempo si sono avvicendati a fare o i panegirici o le critiche.
Nelle qualità caratteriale molti lodano la sua semplicità del suo comportamento, la cordialità del conversare, l'autocontrollo esercitato sul suo temperamento violento e, soprattutto, esaltano la passione per il lavoro che era uno dei suoi tratti più caratteristici; non per nulla un cortigiano lo soprannominò l'"Imperatore insonne ". Si alzava presto e si coricava tardi; pretendeva di conoscere tutto, voleva tutto esaminare per poi con imparzialità e senza superficialità poter decidere con giudizio sereno e con la sua coscienza a posto. Mettendo in questo compito un grande amore per l'ordine, una vera preoccupazione di amministrare bene ogni cosa nei minimi dettagli. Il futuro estensore del "codice" fin dalle prime battute volle diventare "giudice" di se stesso.
Insomma voleva essere all'altezza di svolgere il compito di sovrano nel modo migliore. Aveva un desiderio: di essere contemporaneamente come gli antichi Cesari romani, essere un legislatore e un conquistatore, rifare l'impero da capo con le leggi e se necessario anche con le armi. In più volle diventare come Costantino il campione della religione e capo supremo della chiesa.
E su questa iniziò ad interessarsi in maniera maniacale, leggendo tutto ciò che c'era di meglio e che allora esisteva, facendosi una cultura impressionante di teologia, da poter parlare da pari a pari con vescovi e prelati su questioni da secoli problematiche, irti di ostacoli, cogliendone l'essenziale, e che poi con una oratoria eccezionale esponeva con semplicità sconcertante, riuscendo a calamitare su di sé le attenzioni di tutti.
Per i difetti invece, facciamo per il momento silenzio, alcuni li scopriremo percorrendo anno per anno e fino in fondo, la sua lunga carriera; in base agli storici suoi contemporanei che li hanno evidenziati i suoi limiti, le sue lacune o i suoi errori, chi più chi meno, ognuno sarà poi libero di esprimere un suo giudizio positivo o negativo.
ANNO 518
MORTE DI ANASTASIO A COSTANTINOPOLI
LA NOMINA DI GIUSTINO, UN VECCHIO GENERALE
Il 1° luglio di quest' anno improvvisamente viene a mancare a Costantinopoli l'imperatore.
Il Senato viene in fretta e furia convocato per trovare un degno successore. La successione sarebbe facile, ma in quanto a stimabilità ci sono solo degli inetti lontani nipoti dell'imperatore non certo degni di avere sul capo la corona di Bisanzio. Preferiscono con molta saggezza indicare e poi nominare un altrettanto uomo saggio: un valido militare, che però ha gia 70 anni.
La scelta è caduta sul generale GIUSTINO. Nessuno si ricorda (o non vuole ricordare) di una volontà di Zenone prima e di Atanasio poi, che avevano espresso molti anni prima, cioè che il successore sarebbe stato TEODORICO; l'uomo che entrambi conoscevano fin da bambino; l'uomo che era stato allevato a Costantinopoli; che era poi diventato giovanissimo re degli Ostrogoti; e in questa veste aveva fatto nascere qualche preoccupazione nella corte bizantina.
Zenone che era riuscito a risalire sul trono nel 475, proprio con l'appoggio di Teodorico, per non averlo gratificato a sufficienza (salvo averlo insignito del titolo di patrizio) con lui aveva avuto dei forti contrasti e anche minacce. Ma poi nel 483, scelse la via della conciliazione, si rappacificò con Teodorico, lo nominò militar magister dell'esercito, e lo adottò perfino come figlio (che nella tradizione romana voleva dire essere indicato come successore dell'imperatore)
Fu un riconoscimento privo di sostanza per il giovanissimo re degli Ostrogoti, che ambizioso com'era desiderava allargare il proprio regno sui Balcani. Nel 488 queste sue richieste, che andavano a togliere territori all'impero, crearono un grosso problema a Zenone, soprattutto quando queste richieste furono minacciose. Teodorico occupando la Tracia si era avvicinato un po' troppo a Costantinopoli.
Zenone prevedendo il peggio, fu piuttosto abile nel convincerlo e poi accordarsi di fare una spedizione in Occidente per togliere all'Italia Odoacre. Una ingrato intervento, visto che era stato proprio Odoacre a rimettere le insegne di Roma a Costantinopoli, proprio mentre Zenone era salito sul trono d'Oriente. Per merito di Odoacre, Zenone si trovò così scodellato anche l'impero d'occidente senza aver mosso un dito.
Compito ingrato, ma Zenone non vedeva l'ora di allontanare da sé quell'uomo altrettanto ingrato che prima o dopo lo avrebbe avuto con i suoi ostrogoti sotto le mura delle capitale.
Teodorico aveva accettato, ed era convinto che una volta in Italia, spodestato Odoacre, avrebbe indossato lui la porpora. Ma la sua campagna in Italia - che abbiamo riportato dal 489 in poi- fu lunga, e piuttosto anche incerta, ma poi con l'assassinio a freddo di Odoacre nel 493 riuscì a prevalere insediandosi a Ravenna. Nel frattempo nel corso della lunghissima campagna -nel 491- era morto Zenone. A Costantinopoli per la successione nemmeno presero in considerazione in "figlio adottivo" Teodorico (anche perchè non aveva combinato in Italia ancora nulla) e nominarono dunque Atanasio. Che non andò di certo a rinnovare l'adozione di Teodorico in Italia già da tre anni e contro Odoacre ancora in una situazione piuttosto critica.
Poi, nonostante la vittoria (con l'assassinio, alquanto poco militare come vittoria) il riconoscimento della porpora a Teodorico, da Bizanzio tardava a venire. Sollecitò pure, ma come risposta, dal nuovo imperatore (piuttosto ostile a una ufficiale nomina), ebbe le insegne regali, anche la porpora, ma non una nomina formale.
Pur assolvendo bene il suo lavoro in Italia e oltre i confini, Teodorico non era certo soddisfatto del trattamento. Una insoddisfazione che divenne anche palese quando iniziò a fare alleanze parentali con quasi tutti i regni barbari (da Atanasio in una occasione perfino bocciata)
Alleanze piuttosto ambigue, come abbiamo visto negli scorsi anni; perfino inquietanti, che non sfuggirono nè ai barbari, nè ad Anastasio, e neppure alla corte e nell'ambiente militare di Costantinopoli.
Venuto quest'anno a mancare Anastasio, pur esistendo quell'antica adozione di Zenone, Teodorico alla successione, nessuno dei saggi del Senato (ritornato ad essere molto influente) volle ratificarlo perchè avevano visto negli ultimi tempi non molti buoni reciproci rapporti, né personalmente con Anastasio né con la politica dell'impero stesso.
Scelsero così il comandante delle guardie imperiali GIUSTINO, un uomo di lunga militanza, energico e capace. Questo generale era l'ideale uomo della transizione, data l'età avanzata non doveva rappresentare un problema di lunga durata, nel frattempo avrebbero esaminato bene il da farsi.
Mai più pensavano che questo vecchio signore che non era neppure capace di fare la sua firma, sarebbe diventato un capostipite di una dinastia che avrebbe compreso dal nipote in avanti personaggi che guidarono i destini dell'impero romano d'oriente.
Giustino era un figlio di contadini di un villaggio di Skoplje (bassa Jugoslavia ) ma di razza latina e non slava. Appena raggiunta l'età giovanile, come un avventuriero era sceso da quelle montagne in cerca di fortuna a Costantinopoli. Non trovando nulla di meglio era entrato nell'esercito; prima come semplice soldato, poi graduato, fino ad arrivare con i successivi scatti dopo 50 anni di servizio a diventare generale, il comandante della guardia imperiale, e con tutta quella esperienza che aveva il compito lo assolse bene. Così bene che in questo frangente ai Senatori venne proprio utile.
Da vecchio contadino e conoscendo il mestiere di militare (chissà quante ne aveva sentite dentro e fuori dalle mura) non si fidava nè di quelli del Palazzo, nè dei suoi stessi colleghi, pronti ad appoggiare ora l'uno ora l'altro per venalità o per ragioni di quisquilie religiose che a lui proprio non dicevano nulla, non le aveva mai capite le dispute monofisite o ortodosse, erano cose da preti non da militari.
Non aveva una cultura, ma aveva solo il fiuto di un uomo che ne aveva viste tante, e certamente aveva la furbizia e l'intelligenza visto che era arrivato così in alto in una mansione così delicata come quella della guardia imperiale.
Quindi poco pratico di diplomazia, di politica, di teologia, di amministrazione civile, aveva capito che, pur essendo onorato della scelta, quel posto lo avrebbe soffocato subito se non aveva a fianco un aiuto, un consigliere, un assistente, un collaboratore giovane. Ma di chi fidarsi?
A Skoplje, quando era partito, aveva lasciato una sorella, che aveva un figlio, gli aveva dato perfino il suo nome...
LA NOMINA DI GIUSTINO, UN VECCHIO GENERALE
Il 1° luglio di quest' anno improvvisamente viene a mancare a Costantinopoli l'imperatore.
Il Senato viene in fretta e furia convocato per trovare un degno successore. La successione sarebbe facile, ma in quanto a stimabilità ci sono solo degli inetti lontani nipoti dell'imperatore non certo degni di avere sul capo la corona di Bisanzio. Preferiscono con molta saggezza indicare e poi nominare un altrettanto uomo saggio: un valido militare, che però ha gia 70 anni.
La scelta è caduta sul generale GIUSTINO. Nessuno si ricorda (o non vuole ricordare) di una volontà di Zenone prima e di Atanasio poi, che avevano espresso molti anni prima, cioè che il successore sarebbe stato TEODORICO; l'uomo che entrambi conoscevano fin da bambino; l'uomo che era stato allevato a Costantinopoli; che era poi diventato giovanissimo re degli Ostrogoti; e in questa veste aveva fatto nascere qualche preoccupazione nella corte bizantina.
Zenone che era riuscito a risalire sul trono nel 475, proprio con l'appoggio di Teodorico, per non averlo gratificato a sufficienza (salvo averlo insignito del titolo di patrizio) con lui aveva avuto dei forti contrasti e anche minacce. Ma poi nel 483, scelse la via della conciliazione, si rappacificò con Teodorico, lo nominò militar magister dell'esercito, e lo adottò perfino come figlio (che nella tradizione romana voleva dire essere indicato come successore dell'imperatore)
Fu un riconoscimento privo di sostanza per il giovanissimo re degli Ostrogoti, che ambizioso com'era desiderava allargare il proprio regno sui Balcani. Nel 488 queste sue richieste, che andavano a togliere territori all'impero, crearono un grosso problema a Zenone, soprattutto quando queste richieste furono minacciose. Teodorico occupando la Tracia si era avvicinato un po' troppo a Costantinopoli.
Zenone prevedendo il peggio, fu piuttosto abile nel convincerlo e poi accordarsi di fare una spedizione in Occidente per togliere all'Italia Odoacre. Una ingrato intervento, visto che era stato proprio Odoacre a rimettere le insegne di Roma a Costantinopoli, proprio mentre Zenone era salito sul trono d'Oriente. Per merito di Odoacre, Zenone si trovò così scodellato anche l'impero d'occidente senza aver mosso un dito.
Compito ingrato, ma Zenone non vedeva l'ora di allontanare da sé quell'uomo altrettanto ingrato che prima o dopo lo avrebbe avuto con i suoi ostrogoti sotto le mura delle capitale.
Teodorico aveva accettato, ed era convinto che una volta in Italia, spodestato Odoacre, avrebbe indossato lui la porpora. Ma la sua campagna in Italia - che abbiamo riportato dal 489 in poi- fu lunga, e piuttosto anche incerta, ma poi con l'assassinio a freddo di Odoacre nel 493 riuscì a prevalere insediandosi a Ravenna. Nel frattempo nel corso della lunghissima campagna -nel 491- era morto Zenone. A Costantinopoli per la successione nemmeno presero in considerazione in "figlio adottivo" Teodorico (anche perchè non aveva combinato in Italia ancora nulla) e nominarono dunque Atanasio. Che non andò di certo a rinnovare l'adozione di Teodorico in Italia già da tre anni e contro Odoacre ancora in una situazione piuttosto critica.
Poi, nonostante la vittoria (con l'assassinio, alquanto poco militare come vittoria) il riconoscimento della porpora a Teodorico, da Bizanzio tardava a venire. Sollecitò pure, ma come risposta, dal nuovo imperatore (piuttosto ostile a una ufficiale nomina), ebbe le insegne regali, anche la porpora, ma non una nomina formale.
Pur assolvendo bene il suo lavoro in Italia e oltre i confini, Teodorico non era certo soddisfatto del trattamento. Una insoddisfazione che divenne anche palese quando iniziò a fare alleanze parentali con quasi tutti i regni barbari (da Atanasio in una occasione perfino bocciata)
Alleanze piuttosto ambigue, come abbiamo visto negli scorsi anni; perfino inquietanti, che non sfuggirono nè ai barbari, nè ad Anastasio, e neppure alla corte e nell'ambiente militare di Costantinopoli.
Venuto quest'anno a mancare Anastasio, pur esistendo quell'antica adozione di Zenone, Teodorico alla successione, nessuno dei saggi del Senato (ritornato ad essere molto influente) volle ratificarlo perchè avevano visto negli ultimi tempi non molti buoni reciproci rapporti, né personalmente con Anastasio né con la politica dell'impero stesso.
Scelsero così il comandante delle guardie imperiali GIUSTINO, un uomo di lunga militanza, energico e capace. Questo generale era l'ideale uomo della transizione, data l'età avanzata non doveva rappresentare un problema di lunga durata, nel frattempo avrebbero esaminato bene il da farsi.
Mai più pensavano che questo vecchio signore che non era neppure capace di fare la sua firma, sarebbe diventato un capostipite di una dinastia che avrebbe compreso dal nipote in avanti personaggi che guidarono i destini dell'impero romano d'oriente.
Giustino era un figlio di contadini di un villaggio di Skoplje (bassa Jugoslavia ) ma di razza latina e non slava. Appena raggiunta l'età giovanile, come un avventuriero era sceso da quelle montagne in cerca di fortuna a Costantinopoli. Non trovando nulla di meglio era entrato nell'esercito; prima come semplice soldato, poi graduato, fino ad arrivare con i successivi scatti dopo 50 anni di servizio a diventare generale, il comandante della guardia imperiale, e con tutta quella esperienza che aveva il compito lo assolse bene. Così bene che in questo frangente ai Senatori venne proprio utile.
Da vecchio contadino e conoscendo il mestiere di militare (chissà quante ne aveva sentite dentro e fuori dalle mura) non si fidava nè di quelli del Palazzo, nè dei suoi stessi colleghi, pronti ad appoggiare ora l'uno ora l'altro per venalità o per ragioni di quisquilie religiose che a lui proprio non dicevano nulla, non le aveva mai capite le dispute monofisite o ortodosse, erano cose da preti non da militari.
Non aveva una cultura, ma aveva solo il fiuto di un uomo che ne aveva viste tante, e certamente aveva la furbizia e l'intelligenza visto che era arrivato così in alto in una mansione così delicata come quella della guardia imperiale.
Quindi poco pratico di diplomazia, di politica, di teologia, di amministrazione civile, aveva capito che, pur essendo onorato della scelta, quel posto lo avrebbe soffocato subito se non aveva a fianco un aiuto, un consigliere, un assistente, un collaboratore giovane. Ma di chi fidarsi?
A Skoplje, quando era partito, aveva lasciato una sorella, che aveva un figlio, gli aveva dato perfino il suo nome...
ANNO 517
SIGISMONDO PROMULGA LE SUE LEGGI
I BARBARI SI ADEGUANO IN PARTE AL CORPUS LATINO
Le abbiamo già accennate nelle precedenti pagine in cosa consistevano queste leggi, che ora il nuovo re della Borgundia vuole emanare.
La quasi sudditanza ai re Franchi, voluta e caldeggiata dal vescovo Avito, non è estranea a questa promulgazione. Sigismondo se voleva salire sul trono di suo padre Gondebaldo, doveva accettare l'appoggio dei quattro re franchi, e doveva convertirsi al cristianesimo.
Accettare l'appoggio voleva dire uniformarsi anche alle leggi dei Franchi.
Sigismondo acconsentendo, tutta la politica della sua Borgundia e anche quella religiosa, muta e si affianca a quella già in atto nel regno ereditato dai figli di Clodoveo.
In sintesi erano queste leggi un corpus di norme di diritto romano adattate alle popolazioni locali, che come sappiamo erano anche queste di origine mista, gallo-romana; cioè includevano antiche leggi consuetudinarie borgunde quasi tutte orali, e quelle romane già codificate. Entrambe sacrificavano qualcosa, ma permettevano anche una civile convivenza.
Questo corpo di istituzioni infatti, rispondevano alle esigenze locali, ed erano molto simili a quelle già emanate da Clodoveo, che a sua volta le aveva mutuate da quelle emanate in Italia da Teodorico, sempre impegnato a fare accettare al mondo latino alcune arcaiche leggi consuetudinarie dei popoli germanici.
I BARBARI SI ADEGUANO IN PARTE AL CORPUS LATINO
Le abbiamo già accennate nelle precedenti pagine in cosa consistevano queste leggi, che ora il nuovo re della Borgundia vuole emanare.
La quasi sudditanza ai re Franchi, voluta e caldeggiata dal vescovo Avito, non è estranea a questa promulgazione. Sigismondo se voleva salire sul trono di suo padre Gondebaldo, doveva accettare l'appoggio dei quattro re franchi, e doveva convertirsi al cristianesimo.
Accettare l'appoggio voleva dire uniformarsi anche alle leggi dei Franchi.
Sigismondo acconsentendo, tutta la politica della sua Borgundia e anche quella religiosa, muta e si affianca a quella già in atto nel regno ereditato dai figli di Clodoveo.
In sintesi erano queste leggi un corpus di norme di diritto romano adattate alle popolazioni locali, che come sappiamo erano anche queste di origine mista, gallo-romana; cioè includevano antiche leggi consuetudinarie borgunde quasi tutte orali, e quelle romane già codificate. Entrambe sacrificavano qualcosa, ma permettevano anche una civile convivenza.
Questo corpo di istituzioni infatti, rispondevano alle esigenze locali, ed erano molto simili a quelle già emanate da Clodoveo, che a sua volta le aveva mutuate da quelle emanate in Italia da Teodorico, sempre impegnato a fare accettare al mondo latino alcune arcaiche leggi consuetudinarie dei popoli germanici.
ANNO 516
IL RE DEI BURGUNDI GONDEBALDO MUORE
L'ABILE VESCOVO AVITO, CONVERTE
LA FORMAZIONE DELLA BORGOGNA
GONDEBALDO era stato alleato prima dell'imperatore ANASTASIO e dell'ostrogoto TEODORICO (che su mandato di Costantinopoli ha la reggenza ma non la porpora in Occidente), ma i due entrambi lo avevano deluso quando questa alleanza era stata fatta convinto lui che con il loro aiuto sarebbe riuscito a sottrarsi ai continui attacchi dei Franchi per impossessarsi della sua ricca di vigneti e fertile Borgundia.
Una delusione che lo spinse poi ad allearsi proprio con CLODOVEO (il defunto Re). Come lui anni prima, già aveva preso in seria considerazione di convertirsi alla religione cattolica romana con il solito vescovo di Vienne, AVITO.
Non dimentichiamo che Clodoveo per decenni aveva mirato all'ambito ricco territorio dei Borgundi, ma dopo vari tentativi preferì non scontrarsi con loro ma fare delle oculate alleanza parentali. Infatti sposò nel 493 la principessa burgunda CLOTILDE, proprio la figlia del re borgundo Gondebaldo; una fanciulla che viveva da alcuni anni, fin dall'adolescenza, a Vienne.
Nell'allora capitale borgunda vescovo e suddito di re Gondebaldo era AVITO. Non eccessivamente disturbato da intolleranze, fu lui a iniziare fin da giovinetta la giovane principessa al cristianesimo. E la donna poi andata in sposa a Clodoveo, appena approdata nel regno franco, iniziò a dedicarsi alla conversione del marito, che non voleva respingere la fede dei suoi antenati (lui non era nemmeno ariano ma pagano) ma poi non si oppose quando la moglie alla nascita dei figli volle battezzarli tutti e quattro e con la benedizione del vescovo cristiano cattolico.
L' influenza e la mediazione di Avito e poi di sua moglie Clotilde fu enorme su Clodeoveo, molte considerazioni politiche le potè fare proprio perchè incominciò nel talamo nuziale a scoprire la struttura religiosa del cristianesimo, la sua influenza sulla gente, la organizzazione capillare che si era estesa nei territori, e ampliatasi in una comunità che comprendevano non solo poveri ma anche i ricchi che vedevano nella chiesa un ordine, un'alta autorità morale nel vescovo; autorità che dalla popolazione era accettata senza discussione; le sue prescrizioni erano seguite e ascoltate, con riverenza, con soggezione, ma anche per il timore dei castighi divini che sottintendeva ubbidienza ai comandamenti canonici esortati e ovviamente dal vescovo predicati.
Clodoveo alla fine di questo percorso all'interno del proprio focolare, nel 498, con una grande cerimonia, assieme a 3000 soldati, convertendosi si fece battezzare anche lui dal vescovo Remigio di Reims, abbracciando così il cristianesimo.
Teodorico, quando con i Visigoti appoggiò i Borgundi contro i Franchi, dopo una precaria vittoria, aveva cercato anche lui la strada delle alleanze parentali; lui addirittura si era imparentato con Clodoveo sposando nello stesso 493 (mentre il re dei Franchi sposava la figlia del re dei Borgundi) sua sorella Audofleda; poi -volendo anche lui entrare in quella corte- aveva dato in sposa una sorella a Sigismondo figlio dello stesso Gondebaldo (diventato suocero di Clodoveo) ed erede al trono borgundo; poi una sorella l'aveva data al re dei Visigoti Alarico I; e un'altra ancora al re dei Vandali Trasamondo.
Teodorico insomma aveva messo contemporaneamente un piede dentro in ogni corte (meno che in Italia e a Bisanzio) con amici e nemici. Che servì solo a far nascere tanta diffidenza, soprattutto quando (a nome di Costantinopoli, ma anche autonomamente) si schierava con uno per combattere l'altro o entrambi (come nella battaglia per la riconquista della Provenza a spese dei Borgundi, e la riconquista della Settimania a spese dei Franchi, alleandosi con i Visigoti nel primo caso, e con i Turingi e gli Eruli nel secondo).
Questo voltafaccia i Franchi non l'avevano gradito, nè quando era in vita suo cognato Clodoveo, nè quando il regno Franco fu poi diviso fra i quattro figli. Anzi, già non andavano d'accordo loro, figuriamoci con l'ambiguo Teodorico, così le ostilità nei suoi confronti aumentarono.
Insomma una politica estera quella di Teodorico fallimentare, dove fa già capolino la sua insofferenza per la religione cattolica cristiana che i Franchi hanno già abbracciato e che i Borgundi stanno ora abbracciando. Una insofferenza quella di Teodorico rivolta ai motivi religiosi, forse per cercare degli alibi alle sue fallite manovre militari, miranti a grandiosi progetti pangermanici a fede pagana o ariana.
(una tesi questa avvalorata dal fatto che non fece nessuna alleanza parentale né con i latini né con i bizantini, ma si ostinò a farla solo con i germanici)
L'abile prelato Avito, con capacità diplomatiche non comuni, e con grande autorità morale sempre di più consolidata nei territori barbari, acconsente quest'anno alla morte di Gondebaldo, che salga sul trono trono suo figlio SIGISMONDO, ma a una condizione che regni con l'appoggio dei figli di CLODOVEO, tutti cristiani battezzati.
E soprattutto con uno dei fratelli che è re in Austrasia. Ovviamente altra condizione è l'invito rivolto al giovane e debole re borgundo di convertirsi ufficialmente al cattolicesimo.
La iniziale debolezza del giovane re e altri fattori (lui siederà sul trono per brevissimo tempo) porteranno ben presto (una decina di anni) la Borgundia a far parte definitivamente del regno Franco col nome di Borgogna.
Conquistata del tutto dai Franchi, tornò a costituire un regno separato sotto una dinastia merovingia. Riconquistata da Carlo Martello il territorio fu divisa in due con il trattato di Verdum dell'843: la parte sudorientale più consistente, fu inserita nel regno di Lotario I, mentre quella occidentale, con la città di Autum, divenne un ducato del regno dei franchi.
Dal disfacimento del regno di Lotario derivò alla fine del IX secolo un "regno di Borgogna" che si estendeva a sud fino ad includere anche la Provenza e che veniva chiamato anche regno di Arles, dal nome della sua capitale. Questo fino al 1032, quando del regno divenne titolare l'imperatore tedesco fino al 1363.
Dopo tale data, Giovanni III il Buono di Francia dopo aver creato una grande potenza, costituì anche una dinastia con suo figlio Filippo l'Ardito, e questi grazie a un'accorta politica matrimoniale e alla guerra dei Cento anni, la potenza la estese alla contea imperiale composta dalla Borgogna, dalle Fiandre, dai Paesi Bassi e dal Lussemburgo. Una potenza che riuscì a rivaleggiare poi con quella capetingia fino al 1477. Che è la data della morte di Carlo il Temerario, che pose fine ai sogni di grandezza della sua dinastia..
Solo la Borgogna veniva annessa dalla Francia, tutto il resto invece passò sotto gli Asburgo.
L'ABILE VESCOVO AVITO, CONVERTE
LA FORMAZIONE DELLA BORGOGNA
GONDEBALDO era stato alleato prima dell'imperatore ANASTASIO e dell'ostrogoto TEODORICO (che su mandato di Costantinopoli ha la reggenza ma non la porpora in Occidente), ma i due entrambi lo avevano deluso quando questa alleanza era stata fatta convinto lui che con il loro aiuto sarebbe riuscito a sottrarsi ai continui attacchi dei Franchi per impossessarsi della sua ricca di vigneti e fertile Borgundia.
Una delusione che lo spinse poi ad allearsi proprio con CLODOVEO (il defunto Re). Come lui anni prima, già aveva preso in seria considerazione di convertirsi alla religione cattolica romana con il solito vescovo di Vienne, AVITO.
Non dimentichiamo che Clodoveo per decenni aveva mirato all'ambito ricco territorio dei Borgundi, ma dopo vari tentativi preferì non scontrarsi con loro ma fare delle oculate alleanza parentali. Infatti sposò nel 493 la principessa burgunda CLOTILDE, proprio la figlia del re borgundo Gondebaldo; una fanciulla che viveva da alcuni anni, fin dall'adolescenza, a Vienne.
Nell'allora capitale borgunda vescovo e suddito di re Gondebaldo era AVITO. Non eccessivamente disturbato da intolleranze, fu lui a iniziare fin da giovinetta la giovane principessa al cristianesimo. E la donna poi andata in sposa a Clodoveo, appena approdata nel regno franco, iniziò a dedicarsi alla conversione del marito, che non voleva respingere la fede dei suoi antenati (lui non era nemmeno ariano ma pagano) ma poi non si oppose quando la moglie alla nascita dei figli volle battezzarli tutti e quattro e con la benedizione del vescovo cristiano cattolico.
L' influenza e la mediazione di Avito e poi di sua moglie Clotilde fu enorme su Clodeoveo, molte considerazioni politiche le potè fare proprio perchè incominciò nel talamo nuziale a scoprire la struttura religiosa del cristianesimo, la sua influenza sulla gente, la organizzazione capillare che si era estesa nei territori, e ampliatasi in una comunità che comprendevano non solo poveri ma anche i ricchi che vedevano nella chiesa un ordine, un'alta autorità morale nel vescovo; autorità che dalla popolazione era accettata senza discussione; le sue prescrizioni erano seguite e ascoltate, con riverenza, con soggezione, ma anche per il timore dei castighi divini che sottintendeva ubbidienza ai comandamenti canonici esortati e ovviamente dal vescovo predicati.
Clodoveo alla fine di questo percorso all'interno del proprio focolare, nel 498, con una grande cerimonia, assieme a 3000 soldati, convertendosi si fece battezzare anche lui dal vescovo Remigio di Reims, abbracciando così il cristianesimo.
Teodorico, quando con i Visigoti appoggiò i Borgundi contro i Franchi, dopo una precaria vittoria, aveva cercato anche lui la strada delle alleanze parentali; lui addirittura si era imparentato con Clodoveo sposando nello stesso 493 (mentre il re dei Franchi sposava la figlia del re dei Borgundi) sua sorella Audofleda; poi -volendo anche lui entrare in quella corte- aveva dato in sposa una sorella a Sigismondo figlio dello stesso Gondebaldo (diventato suocero di Clodoveo) ed erede al trono borgundo; poi una sorella l'aveva data al re dei Visigoti Alarico I; e un'altra ancora al re dei Vandali Trasamondo.
Teodorico insomma aveva messo contemporaneamente un piede dentro in ogni corte (meno che in Italia e a Bisanzio) con amici e nemici. Che servì solo a far nascere tanta diffidenza, soprattutto quando (a nome di Costantinopoli, ma anche autonomamente) si schierava con uno per combattere l'altro o entrambi (come nella battaglia per la riconquista della Provenza a spese dei Borgundi, e la riconquista della Settimania a spese dei Franchi, alleandosi con i Visigoti nel primo caso, e con i Turingi e gli Eruli nel secondo).
Questo voltafaccia i Franchi non l'avevano gradito, nè quando era in vita suo cognato Clodoveo, nè quando il regno Franco fu poi diviso fra i quattro figli. Anzi, già non andavano d'accordo loro, figuriamoci con l'ambiguo Teodorico, così le ostilità nei suoi confronti aumentarono.
Insomma una politica estera quella di Teodorico fallimentare, dove fa già capolino la sua insofferenza per la religione cattolica cristiana che i Franchi hanno già abbracciato e che i Borgundi stanno ora abbracciando. Una insofferenza quella di Teodorico rivolta ai motivi religiosi, forse per cercare degli alibi alle sue fallite manovre militari, miranti a grandiosi progetti pangermanici a fede pagana o ariana.
(una tesi questa avvalorata dal fatto che non fece nessuna alleanza parentale né con i latini né con i bizantini, ma si ostinò a farla solo con i germanici)
L'abile prelato Avito, con capacità diplomatiche non comuni, e con grande autorità morale sempre di più consolidata nei territori barbari, acconsente quest'anno alla morte di Gondebaldo, che salga sul trono trono suo figlio SIGISMONDO, ma a una condizione che regni con l'appoggio dei figli di CLODOVEO, tutti cristiani battezzati.
E soprattutto con uno dei fratelli che è re in Austrasia. Ovviamente altra condizione è l'invito rivolto al giovane e debole re borgundo di convertirsi ufficialmente al cattolicesimo.
La iniziale debolezza del giovane re e altri fattori (lui siederà sul trono per brevissimo tempo) porteranno ben presto (una decina di anni) la Borgundia a far parte definitivamente del regno Franco col nome di Borgogna.
Conquistata del tutto dai Franchi, tornò a costituire un regno separato sotto una dinastia merovingia. Riconquistata da Carlo Martello il territorio fu divisa in due con il trattato di Verdum dell'843: la parte sudorientale più consistente, fu inserita nel regno di Lotario I, mentre quella occidentale, con la città di Autum, divenne un ducato del regno dei franchi.
Dal disfacimento del regno di Lotario derivò alla fine del IX secolo un "regno di Borgogna" che si estendeva a sud fino ad includere anche la Provenza e che veniva chiamato anche regno di Arles, dal nome della sua capitale. Questo fino al 1032, quando del regno divenne titolare l'imperatore tedesco fino al 1363.
Dopo tale data, Giovanni III il Buono di Francia dopo aver creato una grande potenza, costituì anche una dinastia con suo figlio Filippo l'Ardito, e questi grazie a un'accorta politica matrimoniale e alla guerra dei Cento anni, la potenza la estese alla contea imperiale composta dalla Borgogna, dalle Fiandre, dai Paesi Bassi e dal Lussemburgo. Una potenza che riuscì a rivaleggiare poi con quella capetingia fino al 1477. Che è la data della morte di Carlo il Temerario, che pose fine ai sogni di grandezza della sua dinastia..
Solo la Borgogna veniva annessa dalla Francia, tutto il resto invece passò sotto gli Asburgo.
Latte di mandorle
Ingredienti | Cosa ci dobbiamo procurare:
- 120 g di mandorle biologiche non spellate
- 1 litro d’acqua (preferibilmente di fonte)
Esecuzione | Come lo prepariamo:
Mettiamo a scaldare un pentolino d’acqua. Quando bolle, versiamoci le mandorle e aspettiamo che l’acqua riprenda il bollore. Scoliamo e passiamo sotto l’acqua fredda. Possiamo cominciare a mondare le mandorle. Prendiamone una fra le dita e sentiremo che la pelle scivola via da sola, espellendo la mandorla come se volesse sfuggirci. Ecco fatto, abbiamo cominciato a spellare le mandorle. Per mondarne 120 g ci vogliono solo 8-10 minuti .Ora mettiamole nella tazza del frullatore, aggiungiamo l’acqua e frulliamo a lungo fino ad ottenere un bel liquido bianco. Prendiamo un pezzo di garza e mettiamola a doppio; bagnamola e strizziamola con cura. Distendiamola in un colino e filtriamo il liquido. Otteniamo così un latte magnifico, adatto a tutti gli usi. Il resto delle mandorle può essere utilizzato per arricchire l’impasto di biscotti o anche essere mescolato ai passati di verdura.Curiosità:
In commercio esistono ottimi latti di mandorle sia in polvere sia liquidi. Tuttavia, il latte preparato in casa, oltre ad essere in linea con lo spirito della cucina medievale, ha proprietà certamente superiori perché contiene preziosi enzimi e vitamine che i prodotti liofilizzati o pastorizzati non hanno o hanno in scarse quantità. Nel caso di prodotti commerciali, assicuratevi che provengano da agricoltura biologica.Attenzione, a volte le mandorle possono non essere tollerate da bambini affetti da allergie. Consultatevi con il vostro medico di fiducia o con il pediatra. La mandorla ha un elevato potere nutrizionale ed energetico.
Brodo di gallina
Ingredienti | Cosa ci dobbiamo procurare:
- 3 litri d’acqua (preferibilmente di fonte)
- 1 bella gallina ruspante di 1,3 – 1,5 kg
- qualche rigaglia di pollo
- 3-4 carote da agricoltura biologica
- 2-3 rape da agricoltura biologica
- 4-5 porri da agricoltura biologica
- 1 grossa cipolla sbucciata e picchiettata con 4 chiodi di garofano
- 1 bel cucchiaino di pepe in grani
- 2 foglie d’alloro
- sale grosso
Esecuzione | Come la prepariamo:
Facciamo preparare la gallina dal pollaiolo. Facciamola legare bene. Mettiamo la gallina e le rigaglie di pollo in un pentolone e ricopriamo con abbondante acqua fredda. Copriamo e portiamo ad ebollizione a fuoco moderato. Quando stacca il bollore, abbassiamo la fiamma al minimo per far sobbollire. Schiumiamo accuratamente finché le impurità affiorano in superficie. Mondiamo le verdure, laviamole e poi aggiungiamole alla carne. Saliamo moderatamente , aggiungimo il pepe in grani e l’alloro e lasciamo cuocere per circa 1 ora e mezzo/ 2 ore. Togliamo la gallina e mettiamola da parte. La si può mangiare con un’agliata o con un’altra salsa medievale. Filtriamo il brodo, mettiamolo a freddare e conserviamo in frigorifero. Il giorno dopo, sgrassiamo togliendo lo strato di grasso superficiale.Curiosità:
Se vogliamo risparmiare tempo, possiamo preparare il nostro brodo utilizzando una comune pentola a pressione. Ricordiamoci però che chi si vuol dedicare, anche se sporadicamente, alla preparazione di piatti medievali, deve dimenticarsi la fretta e la mancanza di tempo, armandosi di tanta calma e pazienza. Pertanto, se vogliamo ottenere un brodo più gustoso e più in linea con lo spirito della cucina antica, dovremmo utilizzare una pentola comune e, ancor meglio, adagiarla sulla piastra rovente di una cucina a legna.Brodo di manzo
Ingredienti | Cosa ci dobbiamo procurare:
- 3 l di acqua (preferibilmente di fonte)
- 800 g di piccione, muscolo, campanello
- 900 g di punta di petto, polso, costole
- 4-5 carote da agricoltura biologica
- 3-4 rape da agricoltura biologica
- 7-8 porri da agricoltura biologica
- 1 bella costa di sedano da agricoltura biologica
- 1 mazzetto di prezzemolo
- 1 grossi cipolla sbucciata e picchiettata con 4 chiodi di garofano
- 3 foglie d’alloro
- 1 bel cucchiaio di pepe in grani
Esecuzione | Come la prepariamo:
Mettiamo le carni, dopo averle lavate accuratamente, in un pentolone e ricopriamo con abbondante acqua fredda. Portiamo ad ebollizione. Abbassiamo la fiamma e facciamo sobbollire. Schiumiamo accuratamente fino ad eliminare tutte le impurità. Mondiamo e laviamo le verdure. Aggiungiamole alla carne insieme all’alloro e al pepe in grani. Saliamo moderatamente e cuociamo a fuoco dolcissimo per circa 3 ore e mezzo. Quando la carne è cotta, togliamola e mettiamola da parte per consumarla da sola. La possiamo mangiare così com’è, accompagnata da alcune salse medievali. Filtriamo il brodo, facciamolo freddare e conserviamolo in frigorifero. Il giorno dopo sgrassiamo levando lo strato di grasso superficiale. Utilizziamolo a seconda delle necessità nelle varie ricette, ove richiesto.Curiosità:
Se vogliamo risparmiare tempo, possiamo preparare il nostro brodo utilizzando una comune pentola a pressione. Ricordiamoci però che chi si vuol dedicare, anche se sporadicamente, alla preparazione di piatti medievali, deve dimenticarsi la fretta e la mancanza di tempo, armandosi di tanta calma e pazienza. Pertanto, se vogliamo ottenere un brodo più gustoso e più in linea con lo spirito della cucina antica, dovremmo utilizzare una pentola comune e, ancor meglio, adagiarla sulla piastra rovente di una cucina a legna.Pasta brisèe
Ingredienti | Cosa ci dobbiamo procurare:
- 250 g di farina da agricoltura biologica
- 125 g di burro da agricoltura biologica
- 10 cl circa di acqua
- 5 g di sale
Esecuzione | Come la prepariamo:
Mescoliamo la farina e il burro freddo tagliato a pezzetti fino ad ottenere la consistenza della segatura. Aggiungiamo l’acqua in cui avremo sciolto il sale e mescoliamo rapidamente con la punta delle dita, senza lavorare troppo, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciamo riposare la pasta così ottenuta in un luogo molto fresco (o in frigorifero) per almeno 2 ore prima dell’utilizzo.Curiosità:
Si tratta di una pasta croccante e friabile, di impiego universale, che va bene per tutte le ricette di torte dolci, torte salate e pasticci che vi presenteremo. Di volta in volta vi verrà indicato se stenderla in modo più o meno spesso sul fondo della teglia, in base al piatto che si andrà a preparare.Pane di campagna
 Ingredienti | Cosa ci dobbiamo procurare:
Ingredienti | Cosa ci dobbiamo procurare:
- 800 g di farina bianca tipo “0”
- 200 g di farina di segale
- 1 cubetto di lievito madre
- 570 g di acqua
- 1 pizzico di zucchero
- 1 pizzico di sale
- una goccia di buon olio d’oliva
Esecuzione | Come la prepariamo:
Procuriamoci 800 g di farina bianca e mescoliamola a 200 g di farina di segale. Mettiamo le farine, preferibilmente biologiche, in una terrina. Aggiungiamovi un pizzico di zucchero, del sale, un pochino di buon olio d’oliva. Pratichiamo un foro al centro della farina, dentro il quale metteremo un cubetto di lievito di birra spezzettato o un pezzetto di pasta madre (che avremo precedentemente preparato con un “laborioso” procedimento). In un pentolino avremo messo ad intiepidire 570 g di acqua; uniamola delicatamente alla farina, amalgamandola inizialmente con il lievito. Impastiamo il tutto con cura e mettiamo a lievitare per almeno 2 o 3 ore in un luogo caldo e tranquillo, applicando sopra la terrina un panno umido. Quando il composto avrà raddoppiato le sue dimensioni, impastiamolo di nuovo, tagliamolo almeno in 2 parti e poniamo ciascuna di esse dentro stampi “a cassetta” per cuocere il pane. Attendiamo una nuova lievitazione. Inforniamo a 200 gradi per circa 30 minuti. Quando la parte superiore sarà ben dorata, il pane è pronto.Suggerimenti:
Quando mettiamo ad intiepidire nel pentolino l’acqua da aggiungere all’impasto, facciamo attenzione a non scaldala troppo: potrebbe causare dei problemi alla lievitazione del pane.Lievito madre
Ingredienti | Cosa ci dobbiamo procurare:
- 200 g di farina di frumento
- 90 g di acqua
- 1 cucchiaio di olio di buona qualità
- 1 cucchiaio di miele
Esecuzione | Come la prepariamo:
Impastiamo tutti gli ingredienti. Mettiamo il panetto così ottenuto in un contenitore, preferibilmente in coccio o in vetro, con coperchio e lasciamo riposare ad una temperatura di circa 22-25° per due giorni. Una volta trascorso questo periodo dobbiamo osservare l’impasto che dovrebbe essere raddoppiato di volume ed avere un profumo acido di lievito. Rinfreschiamo l’impasto prendendo solo 100 g dell’impasto ed aggiungendovi 100 g di farina e 45 g di acqua a temperatura ambiente. Mescoliamo bene e richiudiamo il contenitore. Lasciamo riposare altri due giorni. Trascorso di nuovo questo periodo, rinfreschiamo nuovamente il lievito nello stesso modo, ossia con 100 g di farina e 45 g di acqua a temperatura ambiente. Poniamo quindi l’impasto in frigo e riprendiamolo dopo 5 giorni. Trascorsi i 5 giorni rinfreschiamo ancora allo stesso modo. Fatta questa operazione altre due volte (per un minino di 15 giorni), potremo quindi utilizzare il lievito. Se ne prende una parte e con l’altra si procede ai rinfreschi fino a quando si vuole.Curiosità:
Il lievito madre è un impasto ottenuto dalla fermentazione spontanea di farina di frumento, acqua e zuccheri. Nell’impasto sono presenti inoltre microrganismi di specie diverse: in particolare lieviti del genere Saccaromiceti e batteri lattici; questi ultimi sono, in prevalenza, Lactobacilli e Streptococchi. Questi microrganismi si riproducono alimentandosi di zuccheri semplici (il saccarosio) e, in parte, di zuccheri complessi contenuti nell’amido delle farine; zuccheri che vengono trasformati principalmente in gas (l’anidride carbonica) e, in misura minore, in alcool (l’etanolo), in acido acetico, in acido lattico, in diacetile ed in acetaldeide. L’insieme di questa attività biologiche viene comunemente definita “fermentazione” e costituisce la parte più importante nel processo di produzione delle paste lievitate. L’anidride carbonica prodotta induce un aumento di volume dell’impasto che viene contrastato dalla struttura glutinica della farina che, essendo elastica, si oppone all’espansione del gas di anidride carbonica, racchiudendolo all’interno degli alveoli. Con questo processo si ottiene un impasto poroso che, durante la cottura in forno, si trasforma in prodotto morbido e soffice, conservando a lungo queste qualità che sono la caratteristica dei prodotti ottenuti con le paste lievitate.I rinfreschi sono che dei rabbocchi di farina ed acqua all’impasto base dal quale si sottrae una parte. In sostanza ogni volta che si procede ad un rinfresco si toglie la metà dell’impasto e si aggiunge della nuova acqua e farina. Si rimescola il tutto e si lascia nuovamente riposare.
Suggerimenti:
L’inverno, con i riscaldamenti accesi, è il periodo ideale per questo lavoro in quanto in casa c’è solitamente una temperatura compresa tra i 22 e i 25 °, ideale per il lievito. Quando si utilizza il lievito madre per panificare, occorre inserirne circa un terzo rispetto alla farina, quantità che aumenta lievemente se si utilizzano farine integrali che lievitano meno facilmente.Pasta per pasticci
Ingredienti | Cosa ci dobbiamo procurare:
- 500 g di farina da agricoltura biologica
- 125 g di burro da agricoltura biologica
- 1 uovo fresco
- 20 cl di acqua circa
- 10 g di sale
Esecuzione | Come la prepariamo:
Mescoliamo la farina al burro e aggiungiamo l’uovo e l’acqua nella quale, precedentemente, avremo sciolto il sale. Amalgamiamo bene creando un impasto omogeneo che lasceremo poi riposare, avvolto in un panno, in frigorifero o in luogo fresco.Curiosità:
Si tratta di una pasta di facile esecuzione, gustosa e corposa.Suggerimenti:
Se vogliamo dare alla nostra pasta un gusto più deciso, possiamo sostituire il burro con un’equivalente quantità di strutto. Sarebbe preferibile preparare l’impasto almeno 12-24 ore prima dell’impiego: la pasta, dopo aver riposato, sarà più semplice da stendere e avrà un gusto decisamente migliore. Se poi dobbiamo preparare pasticci abbastanza grandi, basterà semplicemente raddoppiare la dose degli ingredienti.L’Araldica Medievale.

Le Origini.
L'Araldica è l'arte o la scienza dei blasoni: è una scienza in quanto studia le origini, la conformazione degli stemmi e il modo in cui descriverli ed è una un’arte poiché delle insegne ne disciplina uso, forma, figure ed ornamenti. Ma l'araldica è forse meglio descritta come un sistema per identificare gli individui attraverso le insegne ereditarie, questo sistema è originario dell'Europa Occidentale durante il medio Evo. Da fonti archeologiche sappiamo che le insegne sono state usate sugli scudi dai guerrieri per identificarli in battaglia dal Periodo Classico, almeno dall'800 a.c. i Frigi usavano disegni floreali stilizzati sui loro scudi.
Solo nel periodo carolingio però lo stemma assume il suo significato di identificazione individuale, e poi familiare, con la nascita della cavalleria e si è diffuso in tutta l’Europa. L’affermazione dell’Araldica avvenne durante le crociate, in quanto i capitani degli eserciti cristiani della prima crociata (1096-1099), approdati in Asia Minore attraverso il Bosforo, si resero conto che non era possibile mantenere la sola distinzione della croce per tutto l’esercito. Si rendeva necessario quantomeno distinguere i corpi d’armata per nazionalità. Così i vari eserciti assunsero una croce diversamente colorata: quello italiana azzurra, quella tedesca nero e oro, quello francese rossa e poi bianca, quello inglese bianca e poi rossa, i fiamminghi e i sassoni verde. Tuttavia l'araldica deve con ogni probabilità la propria origine allo sviluppo dell'armatura durante il Medioevo. Una semplice croce colorata permetteva infatti di distinguere la nazionalità del singolo cavaliere: ma nella battaglia era anche necessario riconoscere i cavalieri che si distinguevano per coraggio: o quelli che al contrario che evitavano il combattimento per viltà o quelli che venivano catturati, feriti o uccisi nella mischia. Fino a quando furono usati gli elmi a bacinetto, che lasciavano scoperto il viso, era possibile riconoscere il cavaliere, ma quando cominciarono ad essere usati gli elmi a becco di passero, a celata, a cancello, non vi fu modo di individuare il combattente. Si pensò allora di porre un segno distintivo per ciascun cavaliere: un simbolo che fosse adottato esclusivamente da un guerriero, il quale da quel momento sarebbe stato identificato a mezzo delle insegne che portava sul suo scudo, sull’elmo, sulla sopravveste o sulla gualdrappa del proprio cavallo. Per far ciò si rispolverarono gli elementi che caratterizzavano le famiglie: cioè quei simboli che ancora non costituivano uno stemma e che soltanto allora furono legati indissolubilmente al cavaliere: un binomio che diede origine all’araldica la quale divenne a porre ordine in un complesso e variopinto universo simbolico.

Lo Sviluppo dell’Araldica.
Non tutti i cavalieri disponevano però di insegne di famiglia: il novello cavaliere senza stemma avito aveva lo scudo di un solo colore, il cosiddetto "scudo o tavola di aspettazione", e attendeva di caricarlo con gli elementi che si ritenevano via via più pertinenti ed opportuni. Alcuni "cadetti" delle grandi famiglie portavano lo scudo con le insegne familiari coperto da un velo: potevano scoprirlo solo dopo un’azione valorosa. Il cavaliere vittorioso in battaglia aveva il diritto di fregiarsi delle insegne catturate al nemico vinto, ponendole sul proprio scudo. Era sufficiente un’azione vittoriosa per aver titolo a prendere i segni della vittoria. Già nel 1275 Raimondo Lullo, nel "Libro dell'Ordine della Cavalleria", afferma che il "blasone che sta sullo scudo, sulla sella e sulla cotta del Cavaliere è il segno di riconoscimento delle ardite azioni che ha condotto e del colpi che ha menato in battaglia". Ad esempio conquistando le mura di un castello si poteva inserire nello scudo la figura della torre o della cinta merlata, oppure l’immagine della scala che era servita a salire sugli spalti per espugnare la fortezza: chi poteva vantare la propria partecipazione alle Crociate, oppure avi che vi avevano partecipato, spesso ornava il proprio scudo con la croce o con teste di moro. Lo stesso fecero in seguito i nobili ungheresi che, difensori della cristianità contro gli ottomani, spesso fregiarono i propri stemmi di turchi con la testa infilzata su spade, sbranati da leoni e così via, dando vita ad una araldica piuttosto sanguinaria, ma pittoricamente efficace. Come le imprese militari, anche quelle amorose costituirono presto elementi di distinzione: i cuori spesso facevano bella mostra sullo scudo del cavaliere innamorato, cosi come le rose (o altri fiori), le colombe, le fiamme, la fornace, le frecce: tutti simboli dell' amore ardente. Spesso il colore del velo o del fazzoletto di una damigella che, da spettatrice, partecipava ad un torneo, ad una giostra, andava a connotare lo scudo di qualche cavaliere ancora alla ricerca del distintivo araldico definitivo. Ben presto, però, le figure in uso, sebbene assai numerose, non furono più sufficienti ad esprimere il moltiplicarsi del cavalieri. Si dovettero perciò creare nuove forme di distinzione. La croce assunse allora le forme più svariate e le colorazioni più disparate e nel blasone cominciarono ad entrare nuove figure quali draghi unicorni, sirene, grifoni, animali fantastici e mostruosi che verranno successivamente definiti chimerici. Con il trascorrere del tempo altre figure si aggiunsero a quelle in uso e si cominciò a far ricorso alle partizioni che raccoglievano nello scudo più elementi: dalla Spagna venne poi l’uso di “inquartare” gli scudi, creando insegne sempre più complesse. Alcuni assunsero emblemi corrispondenti al nome (stemmi parlanti), altri nomi corrispondenti all'emblema: in effetti l'uso della stemma è grossomodo contemporaneo (e in alcuni casi precedente) a quello del cognome.

Lo stemma era pertanto sia carta di identità sia memoria storica delle imprese da lui compiute: una sorta di biglietto da visita. Possiamo quindi distinguere due periodi: una prima fase in cui si registra la trasformazione di motivi decorati dipinti su scudi in emblemi personali (1100-1140) e una seconda che vede la trasformazione di questi ultimi in emblemi ereditari soggetti a regole precise (1140-1180). Dal 1230 circa tutte le comunità civili, ecclesiastiche e militari nonché tutte le altre categorie sociali (le donne in particolare), cominciarono ad usare i simboli araldici negli emblemi. Nelle città lo stemma veniva utilizzato per indicare il possessore di un immobile. Infatti non é raro trovare case: torri palazzi che recano agli angoli uno stemma: in modo da definire con precisione i confini della proprietà, stretta com’era fra altri (e altrui!) edifici. Solo dalla seconda meta del 300 gli stemmi furono raffigurati anche sulle facciate e sui portali. L'araldica inoltre identificava anche le province dell’impero, le città del periodo comunale, gli ecclesiastici (dal papa al semplice sacerdote), le confraternite e gli ordini cavallereschi, le signorie, le associazioni di lavoro come le arti e le gilde. Gli stemmi cittadini riprendevano con una certa frequenza quelli dei rispettivi signori (ad esempio Basilea, in Svizzera, porta ancora sub stemma il Pastorale del Vescovo suo antico signore), mentre quelli delle corporazioni riprendevano spesso strumenti o animali attinenti al mestiere dei loro rappresentati. Regole fisse e particolari si consolidarono ad opera degli araldi a partire dal XIV secolo. In questo secolo si cominciò ad indossare sopra l’armatura a maglie un abito di stoffa con le insegne familiari: da questa abitudine deriva la “coat of arms", ii termine anglosassone per blasone, insegna, stemma. Solo dal 1390 in Inghilterra il diritto di portare un certo stemma divenne ereditario. Dal 1400 per essere ammessi a partecipare ad un torneo era necessario portare uno stemma e a causa dell’importanza sociale di questi eventi un’insegna diventò ben presto indice di nobiltà. Tuttavia la maggior parte degli stemmi venivano semplicemente adottati senza essere concessi da una alcuna autorità. Edoardo IV, nel 1483, regolamentò l'iniziale libertà di scelta e uso delle insegne facendo carico di questo il College of Heralds di Londra e nel 1488 suo fratello Riccardo affidò a questo istituto le ricerche genealogiche e il compito di confermare titoli onorifici nonché di approvare e registrare gli stemmi.

Gli Araldi sono esistiti probabilmente dal 1132, ma i loro compiti all'inizio consistettero solitamente nell'esaltare le imprese dei cavalieri nei tornei. Essi diventarono subito responsabili nel proclamare e organizzare questi tornei, così popolari nel 12° sec., e conseguentemente divennero esperti di Araldica il cui lavoro era di identificare i contendenti dalle insegne dipinte sui loro scudi e vessilli. Nacque così la Blasonatura, ossia l'azione di descrivere e perfino decifrare i blasoni. Questa lettura è eseguita secondo un ordine molto rigoroso, per cui in linea di principio ad ogni blasone dato corrisponde uno ed un solo testo. In questo periodo questi Araldi erano simili a Menestrelli, che vagabondavano da paese a paese alla ricerca dei tornei, venendo a conoscenza di ogni personaggio di una certa importanza attraverso l'Europa. Dalla conoscenza dei grandi uomini del loro tempo deriva la loro utilità nei comandi militari, e i manoscritti medievali menzionano araldi presenti alle Battaglie di Drincourt (1173) e Las Navas di Tolosa (1212), sebbene non si faccia cenno agli Araldi nel servizio reale fino alla fine del 13° secolo. Visto il valore di uomini che potevano identificare i contingenti di eserciti opposti dagli scudi e i vessilli, spinse quasi ogni cavaliere ad assumere un araldo, non importava quanto piccola fosse la forza che egli comandava. Il compito di questi Araldi era di stare costantemente vicino al loro signore (nelle campagne alloggiavano nella tenda del signore) per essere a portata di mano per rispondere agli domanda inerente l'identità di un cavaliere, e dall'inizio del 14° secolo ciò provocò la loro elevazione da menestrelli vagabondi ad ufficiali scelti e confidenti delle case nobili; dalla metà del secolo gli Araldi in Francia ed Inghilterra avevano acquisito uno status stabile. Comunque, in Germania gli Araldi furono lenti ad acquisire un riconoscimento ufficiale almeno fino al 1338 senza una chiara divisione tra menestrelli e Araldi. Dalla metà del 14° secolo gli Araldi erano continuamente impiegati da re e principi di Europa, entrambi in pace e tempo di guerra. Infatti il loro doppio ruolo di Araldi e inviati con immunità diplomatica stava diventando incompatibile dalla fine del secolo. Per rimarcare il loro ufficio gli araldi indossavano una livrea con i simboli del signore che servivano. Più tardi essi diventarono anche responsabili nell'organizzare i matrimoni e funerali della nobiltà, così come altre cerimonie e cortei. Tuttavia a dispetto del loro status e indubbia importanza in tutte le questioni collegate all'araldica, fino alla fine del 14° secolo gli araldi inglesi non ebbero controllo sul disegno dei blasoni, essendo solamente responsabili della loro registrazione e riconoscimento.

Quando nel 1500 cominciarono a scomparire sia i tornei sia gli elmi chiusi, gli usi sportivi e militari degli stemmi divennero meno importanti e l’araldica divenne quasi un’arte decorativa: le insegne furono incise su portoni, ricamati su tappezzerie, istoriate in vetrate e incise su argento. Quando ciò accadde, da circa il 1550, l'era della vera Araldica era terminata e successivamente questa scienza andò in declino: i sigilli non erano più così importanti a causa della diffusione dell'alfabetismo, e l'identificazione veniva ora realizzata dall'uso delle bandiere, e nelle giostre dall'uso degli stemmi. I Blasoni vennero all'inizio usati solo dai re e principi, poi dai grandi nobili. Dalla metà del 13° secolo vennero invece usati ampiamente dai nobili minori e cavalieri e in alcuni paesi si diffusero tra mercanti e cittadini, e perfino tra i contadini. Chiunque decidesse di avere un blasone semplicemente ne inventava uno, sebbene spesso fosse basato sui simboli del signore feudatario. Dal primo quarto del 14° secolo avvennero due sviluppi: il primo fu che ogni uomo poteva adottare un blasone e il secondo che potevano portarli solamente i nobili per loro esclusivo diritto. Nacquero così delle dispute provocate dalla duplicazione dei simboli in cui gli Araldi non furono coinvolti , ma dal 14° secolo i 'Kings of Heralds' stavano raccogliendo in una raccolta tutti i blasoni esistenti nelle loro province, rilevando la presenza di duplicazione su cui veniva richiesta una sistemazione. Le dispute sul diritto di portare un dato blasone portò alla necessità di creare un'autorità in grado di regolamentarne l'assegnazione. Molti araldi collezionarono un gran numero di stemmi, creando cosi le prime raccolte di insegne o armoriali. In Inghilterra fra il 1580 e il 1686 gli Araldi del College of Heralds istituirono delle visite in tutto il Paese con lo scopo di raccogliere, osservare, dichiarare e registrare tutti gli stemmi che venivano portati.
Si noti the il termine Heraldry (Araldica) non viene usato se non a partire dal XVIII secolo tranne per due eccezioni: Guillim (cit.: 1611) e MacKenzie (cit., 1662) che usa un termine simile: Herauldry. Fino al XV secolo: l’uso di "timbrare" lo scudo, ovvero di apporre elmi, cimieri, svolazzi, lambrecchini...: era dovuto soltanto a questioni estetiche. Poiché per il fatto di avere un insegna non discendeva dall’appartenenza ad uno stato sociale (quello dei cavalieri, o all' aver compiuto atti di particolare valore militate: i nobili spesso ridotti in povertà cercarono di diversificare le proprie armi utilizzando proprio le timbrature come elemento qualificatore del proprio stato. Fu cosi che nella Francia del 1535: un mandamento di Francesco I stabili che soltanto i nobili potevano timbrare ii proprio scudo. Questa Legge sebbene più volte confermata nel corso degli anni fu poco seguita: in effetti fino al XVIII secolo l’uso di una timbratura non sembra essere affatto sinonimo di nobiltà. L'editto del novembre 1696 di Luigi XIV di Francia: stabiliva che entro due mesi tutti i nobili, gli ecclesiastici, le amministrazioni, corporazioni, istituzioni, gli ordini religiosi, i borghesi ecc. dovevano registrare le proprie insegne. I trasgressori sarebbero stati puniti con un’ammenda di 300 lire. Poiché a questa registrazione erano tenuti anche tutti coloro che per merito personale avevano un titolo d'onore o di distinzione, tutti coloro che possedevano (o usavano) uno stemma andarono a farlo registrare presso uffici addetti a questo scopo. Il risultato di questo censimento paragonabile per importanza alle visite degli araldi inglesi che abbiamo visto precedentemente organizzazione dell’Armorial general. Chi in seguito avrebbe voluto acquisire un'insegna, avrebbe dovuto pagare un’imposta di registrazione fissato a circa 20 lire. Chi desiderava apporre modifiche successivamente dovesse pagare la stessa somma. Malgrado la minaccia di ammende, le registrazioni non furono affatto numerose e quelle effettuate furono dovute, soprattutto ai nobili e ai religiosi. II 3 dicembre 1697 il Consiglio di Francia obbligò tutti gli "abili a portare un'insegna" e a registrarla entro 8 giorni, altrimenti sarebbe stata loro concessa d'ufficio (in base al mestiere, al nome, alla categoria sociale), dietro il pagamento della stessa tassa. Fu cosi che anche chi non avrebbe mai pensato di portare uno stemma, fu costretto ad adottarne uno. In questa occasione videro la luce blasoni particolarmente divertenti, che persino gli involontari proprietari si vergognavano ad usare, ad esempio un farmacista bretone si vide assegnare uno scudo con sfondo azzurro e come simboli una siringa d'argento accompagnata da tre pitali.

Iscriviti a:
Commenti (Atom)